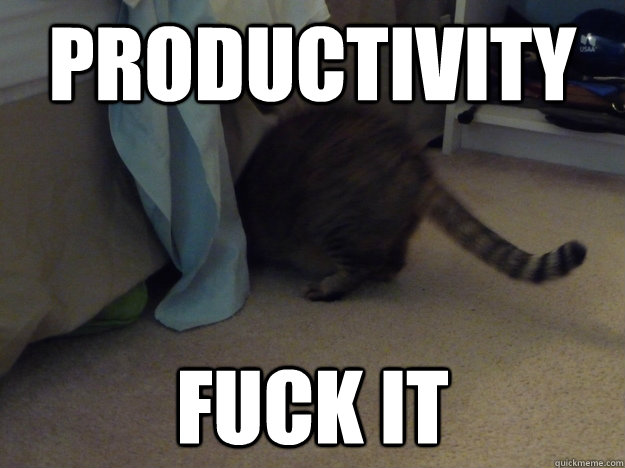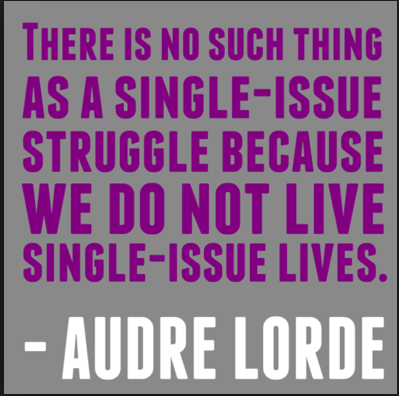Di seguito potete leggere un articolo di Pendleton Vandiver, “Feminism: a male anarchist’s perspective“, presente su The Anarchist Library e tradotto in lingua italiana da Su Macumeresu. Buona lettura!
“Io stessa non ho mai capito cosa sia il femminismo: so solo che mi chiamano femminista quando esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino”
Rebecca West, The Clarion 1913

La maggior parte delle persone nel mondo anarchico attuale – femmine o maschi – non condividerebbero, almeno in principio, molte delle seguenti affermazioni: ci sono due categorie immutabili e naturali sotto le quali gli umani sono classificati: maschio e femmina. Un umano maschio è un uomo, e un umana femmina è una donna. Le donne sono intrinsecamente inferiori agli uomini. Gli uomini sono più intelligenti e forti delle donne; le donne sono più emozionali e delicate. Le donne esistono per il beneficio dell’uomo. Se un uomo chiede del sesso a sua moglie, è suo dovere obbedire, volente o nolente. Un uomo può costringere una donna a fare sesso con lui, se ha una buona ragione per richiederlo. Gli umani devono essere concepiti, in senso universale, come maschi (“uomini”), e solo parlando di particolari individui come femmine. Le donne sono una forma di proprietà. Chiedere diritti per le donne è come chiedere diritti per gli animali ed è altrettanto assurdo.
Per quanto ridicole possano sembrare queste affermazioni, ognuna di loro è stata ovvia e naturale per buona parte dell’occidente in diversi momenti storici, e molte al giorno d’oggi sono più una regola che un’eccezione. Se molte di queste sembrano un po’ strane, stridenti o semplicemente sbagliate, non è perché contraddicano qualche vaga nozione di giustizia o senso comune con la quale siamo nati. Al contrario, il cambiamento di atteggiamento, che ci permette di affermare un punto di vista più illuminato e apparentemente naturale, è il risultato concreto di una continua lotta che ha visto sacrificarsi onorabilità e relazioni personali e vite umane negli ultimi 200 anni e che, come tutte le lotte di liberazione, è stata screditata, calunniata, e marginalizzata fin dal suo concepimento. Sebbene questa lotta sia stata, e ancora sia, strategicamente varia e concettualmente molteplice, e per questo difficile da definire, non è altrettanto difficile chiamarla col suo nome: mi riferisco, naturalmente, al femminismo.
Il femminismo ha cambiato la nostra cultura, se non altro rendendo di senso comune l’idea che le donne sono propriamente degli esseri umani. Se la maggior parte della gente condivide questa idea, non è perché la società sia diventata più buona, o stia evolvendo naturalmente verso una situazione più egalitaria. Chi ha il potere non decide semplicemente di concedere l’uguaglianza a quelli che non ce l’hanno; semmai, cede il potere solo quando vi è costretto. Le donne, come ogni altro gruppo oppresso, hanno dovuto prendere tutto ciò che hanno ottenuto, attraverso un duro percorso di lotta. Negare questa lotta è perpetuare un mito simile a quello dello schiavo felice. Ed è precisamente ciò che facciamo quando parliamo di femminismo come di un qualcosa che perpetua il divario di genere, o che ostacola il nostro progressivo abbandono delle politica identitaria. Il femminismo non ha creato il conflitto tra i generi; la società patriarcale lo ha creato. Ed è importante non dimenticare che l’idea che le donne siano esseri umani non è senso comune, ma in tutto e per tutto un concetto femminista. Appoggiare formalmente la liberazione delle donne, mentre si nega la loro lotta storica per ottenerla per sé stesse è paternalista e insultante.
Non solo la società occidentale ha apertamente relegato le donne a un ruolo subumano, ma, fino a poco tempo fa, molti movimenti di liberazione hanno fatto lo stesso. Spesso, è stato fatto in parte senza saperlo, come riflesso automatico dei costumi della cultura dominante. Altrettanto spesso, però, è stato in modo consapevole e intenzionale (come la famosa affermazione di Stokely Carmichael [leader studentesco statunitense e in seguito Black Panther, ndt], per cui l’unica posizione per le donne nel Comitato Coordinamento Studenti Nonviolenti fosse “in ginocchio”). Comunque sia, molti tra quelli che dicevano di lavorare per l’emancipazione di tutti gli umani stavano in realtà lavorando per l’emancipazione dell’uomo, e fino a poco tempo fa la definizione era proprio questa. Alle donne che si lamentavano di questo veniva (e viene tuttora) detto in modo accondiscendente di aspettare finché la battaglia più importante venga vinta, prima di chiedere la loro propria liberazione. Questo è stato per l’abolizionismo [della schiavitù], i diritti civili, il movimento contro la guerra, la Nuova Sinistra [americana], il movimento contro il nucleare, l’ambientalismo radicale e, ovviamente, l’anarchismo. Le donne sono state criticate per aver perseguito obiettivi femministi come se fossero nella direzione sbagliata, controrivoluzionari, o non importanti. Gli anarchici non si sono semplicemente svegliati una mattina con una visione più illuminata delle donne, e il patriarcato non si è rivelato improvvisamente come “un’altra forma di dominazione”. Sono state la teoria e la pratica femminista a portare alla luce l’oppressione delle donne, che l’hanno spesso manifestata in ambiti rivoluzionari differenti.
Questo non vuol dire che tutte le femministe fossero e siano anarchiche, o che tutti gli anarchici non fossero e non siano femministi. Ma il femminismo è spesso criticato nell’ambiente anarchico, da diversi punti di vista. Proverò a discutere le più comuni critiche che ho sentito fare, pubblicamente e privatamente, nei circoli anarchici. E’ stato detto che il femminismo è essenzialista. E’ stato anche detto che il femminismo, mantenendo le sue visioni essenzialiste, è una filosofia che afferma la superiorità, in un modo o nell’altro, delle donne sugli uomini. Infine, si accusa il femminismo di perpetuare le categorie di genere, mentre l’obiettivo rivoluzionario sarebbe andare oltre il genere. In altre parole, il femminismo è accusato di essere un’ideologia identitaria, di perpetuare ruoli sociali dolorosi ed escludenti che in ultima analisi opprimono tutti.
Ciò che queste accuse hanno in comune è che stabiliscono un’entità singola e più o meno univoca chiamata “femminismo”, mentre chiunque studia il femminismo impara subito che c’è sempre stata molta varietà nella teoria femminista, e che questo è vero soprattutto adesso. Nessun singolo insieme di idee sul sesso e sul genere rappresenta il femminismo; anzi, il femminismo è una categoria aperta, che comprende praticamente tutte le forme di pensiero e azione che riguardano esplicitamente la liberazione delle donne.
Sebbene il femminismo sia stato spesso accusato di essenzialismo, quest’ultimo è fortemente criticato all’interno del movimento femminista. L’essenzialismo è l’idea che ci sia una sostanza o essenza immutabile che costituisce la vera identità delle persone e delle cose. In questa visione, una donna sarebbe in qualche modo obiettivamente, profondamente identificabile come donna; essere una donna non sarebbe semplicemente il risultato di differenti attributi e comportamenti. Questa è spesso letta come un’affermazione politicamente arretrata, perché implicherebbe che le persone siano limitate da certe capacità e comportamenti dettati dalla natura.
Quando esaminiamo il campo delle idee emerse dalla seconda ondata del femminismo (più o meno post-1963), invece, viene fuori un’immagine diversa. La citazione forse più famosa del ‘Secondo sesso’, l’opera seminale di Simone de Beauvoir del 1940, è: “donne non si nasce, lo si diventa”. Il libro prosegue argomentando che il genere è una categoria sociale, che gli individui possono rifiutare. L’influenza del ‘Secondo sesso’ è stata enorme, e Beauvoir non fu l’unica femminista a mettere in dubbio la naturalità della categoria di genere. Molte scrittrici femministe iniziarono a tracciare una distinzione tra il sesso e il genere, asserendo che il primo descrive il corpo fisico, mentre il secondo è una categoria culturale. Per esempio, avere un pene appartiene al sesso, il modo in cui uno si veste, e il ruolo sociale che sceglie, appartiene al genere.
E’ una distinzione che alcune femministe ancora fanno, ma altre hanno messo direttamente in dubbio l’uso di categorie apparentemente pre-culturali come il sesso. Colette Guillamin ha suggerito che il sesso (come la razza) è un sistema arbitrario di “marchi” che non ha alcun fondamento in natura, ma serve semplicemente gli interessi di chi ha il potere. Sebbene varie differenze fisiche esistano tra le persone, è politicamente che si decide quali siano importanti per ‘definire’ una persona. Per quanto gli individui siano divisi in categorie ‘naturali’ sulla base di questi marchi, non c’è nulla di naturale nelle categorie: sono puramente concettuali.
Basandosi sul lavoro di de Beauvoir e Guillamin, tra le altre, Monique Wittig ha affermato che l’obiettivo del femminismo è eliminare il sesso e il genere come categorie. Come il proletariato nella filosofia marxista, le donne devono costituirsi in classe per rovesciare il sistema che permette l’esistenza delle classi. Non si nasce donna, se non nello stesso senso in cui si nasce proletari: essere donna denota una posizione sociale, e certe pratiche sociali, più che un essenza o un’identità ‘vera’. Il fine politico ultimo di una donna, per Wittig, è non esserlo. Più di recente, Judith Butler ha elaborato un’intera teoria di genere basata sulla radicale espulsione dell’essenza.
Naturalmente, ci sono state femministe che, disturbate da quella che vedevano come tendenza assimilazionista nel femminismo, hanno asserito una nozione di femminilità più positiva che è stata, a volte, indubbiamente essenzialista. Susan Brownmiller, nel suo importante libro ‘Contro le nostre volontà’, ha scritto che gli uomini possano essere geneticamente predisposti allo stupro, una nozione che è stata ripresa da Andrea Dworkin. Femministe marxiste come Shulamite Firestone cercarono la base materiale dell’oppressione di genere nel ruolo riproduttivo femminile, e molte teoriche femministe – Nancy Chodorow, Sherry Ortner, Juliet Mitchell tra le altre – hanno esaminato il ruolo della maternità nel creare ruoli di genere oppressivi. Femministe radicali come Mary Daly hanno abbracciato certe nozioni tradizionali di femminilità e hanno cercato di dar loro un senso positivo. Sebbene le radicali abbiano, a volte, preso posizioni essenzialiste, questo tipo di femminismo ha compensato alcuni degli squilibri di questo ambito del pensiero femminista che rifiutava la femminilità tout court come identità da schiava. La dicotomia che ha arrovellato le pensatrici femministe è sempre stata questa: asserire una forte identità femminile, e rischiare di legittimare i ruoli tradizionali e alimentare chi impiega l’idea di una differenza naturale per opprimere le donne, o rifiutare il ruolo e l’identità data alle donne, e rischiare di eliminare la base propria della critica femminista? L’obiettivo del femminismo contemporaneo è trovare un equilibrio tra punti di vista che rischiano, da una parte, l’essenzialismo, e dall’altra l’eliminazione delle donne come soggetto della lotta politica.
L’obiettivo del femminismo, quindi, è la liberazione della donna, ma cosa questo significhi esattamente è aperto a ogni discussione. Per alcune, questo significa che le donne e gli uomini debbano coesistere equamente; per altre, che non ci saranno più persone viste come donne e uomini. Il femminismo fornisce un ricco panorama di vedute sul problema di genere. Una cosa su cui possono accordarsi, comunque, è che i problemi di genere esistono. Sia come risultato di differenze naturali o di costruzioni culturali, le persone sono oppresse per motivi di genere. Per andare oltre al genere, questa situazione deve essere risolta; il genere non può semplicemente essere battezzato come sorpassato. Il femminismo può forse essere meglio definito come il tentativo di andare oltre la situazione in cui le persone sono oppresse in base al genere. Quindi, non è possibile andare oltre il genere senza il femminismo; l’accusa che il femminismo perpetui le categoria di genere è palesemente assurda.
Poiché l’anarchismo si oppone a tutte le forme di dominazione, l’anarchismo senza femminismo non è anarchismo. Poiché l’anarchismo si dichiara opposto a tutte le ‘archie’, tutti i governi, il vero anarchismo è per definizione opposto al patriarcato, quindi è, per definizione, femminista. Ma non è abbastanza dichiararsi contro tutte le dominazioni; si deve cercare di conoscere la dominazione per opporsi ad essa. Le autrici femministe dovrebbero essere lette da tutti gli anarchici che si considerano contro il patriarcato. Le critiche femministe sono sicuramente rilevanti quanto i libri contro l’oppressione governativa. L’eccellente ‘Agenti di repressione’ di Ward Churchill è considerato una lettura essenziale da molti anarchici, anche se Churchill anarchico non è. Molti lavori femministi, d’altra parte, sono snobbati anche da chi appoggia formalmente il femminismo. Se la repressione della polizia è una vera minaccia per gli anarchici, il modo in cui interpretiamo i nostri ruoli di genere deve essere considerato ogni giorno della nostra vita. Quindi, la letteratura femminista è più importante per la lotta quotidiana contro l’oppressione di molta della letteratura che gli anarchici leggono regolarmente.
Se l’anarchismo ha bisogno del femminismo, il femminismo ha sicuramente bisogno dell’anarchismo. Il fallimento di alcune teoriche femministe nel combattere il dominio oltre il ristretto frame delle donne vittimizzate dagli uomini ha impedito loro di sviluppare un’adeguata critica dell’oppressione. Come ha scritto un importante scrittore anarchico, un’agenda politica basata sul chiedere agli uomini di rinunciare ai loro privilegi (come se fosse davvero possibile) è assurdo. Femministe come Irigaray, MacKinnon e Dworkin sostengono riforme legislative, senza criticare la natura oppressiva dello Stato. Il separatismo femminista (specie quello di Marilyn Frye) è una strategia pratica, e forse necessaria, ma solo nella cornice di una società ampia che si assume stratificata sulla base del genere. Il femminismo è davvero radicale quando cerca di eliminare le condizioni che rendono inevitabile l’oppressione di genere.
Anarchismo e femminismo chiaramente hanno bisogno l’una dell’altro. E’ tanto bello dire che una volta che la fonte primaria di oppressione (qualunque essa sia) sarà eliminata, tutte le altre oppressioni saranno spazzate vie, ma che prove abbiamo che sia davvero così? E in che modo questo dovrebbe impedirci di opprimerci l’uno con l’altro, mentre aspettiamo questa grande rivoluzione? Allo stesso modo, è importante riconoscere che l’oppressione della donna non è l’unica oppressione. Discutere di quale sia quella più importante è sciocco e senza uscita. Il valore e la pericolosità dell’anarchismo sta proprio nel fatto che cerca di eliminare tutte le forme di dominazione. L’obiettivo ha valore perché non si distrae con battaglie riformiste dimenticando la sua traiettoria verso la liberazione totale. Ma, in un altro senso, è ‘pericoloso’ perché corre sempre il rischio di ignorare le situazioni concrete, sottovalutando o escludendo movimenti che lottano per obiettivi specifici.