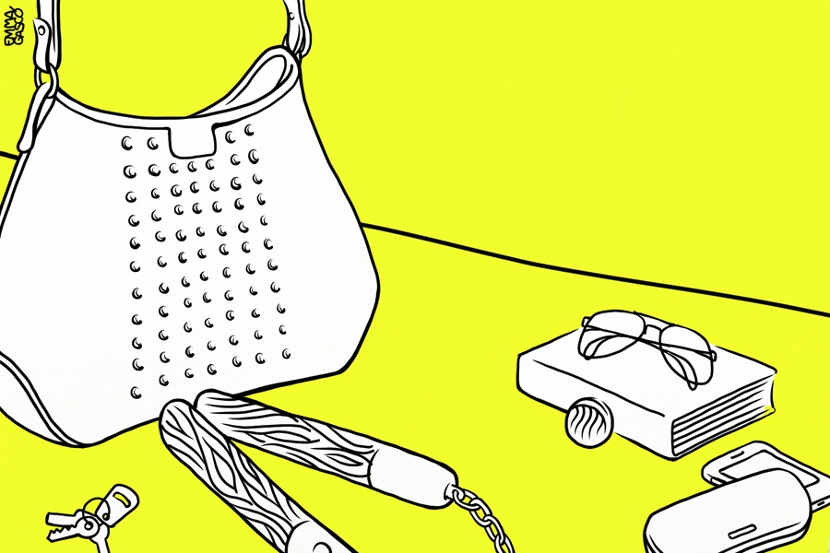Leggendo questo titolo, molte persone avranno pensato alla violenza contro le donne, che è tanta. Tuttavia voglio riferirmi alla violenza che queste esercitano o, meglio, a quella che potrebbero esercitare in propria difesa, una violenza quasi inesistente, sia organizzata in gruppi, sia esercitata in modo individuale. La domanda che mi faccio sempre è: Perché le donne raramente usano la violenza contro un sistema patriarcale che è così violento contro di loro?
Assistiamo continuamente a scene di violenza contro le donne: reale e romanzata. Abbiamo visto video o immagini di fustigazione, lapidazione, abusi fisici e abbiamo visto le donne camminare per le strade di alcuni paesi sotto un burka. Ogni pochi giorni, in questo paese, una donna viene uccisa da un uomo, e spesso vediamo donne reali con ematomi reali. Vediamo anche molte immagini romanzate di stupro, pestaggi e omicidi, in film o telefilm. Nella nostra cultura globale il maltrattamento delle donne è molto comune ed è assolutamente diffuso. La violenza contro le donne non è sorprendente, conviviamo con essa, è un’immagine quotidiana e reale; ci accompagna costantemente. E nonostante ciò, questa campagna mi ha colpito, mi ha scosso, mi ha fatto male:
E mi ha fatto pensare, ancora una volta, a una domanda che mi sono fatta molto spesso: Perché le donne non si sono mai organizzate con la violenza per difendersi dalla violenza perpetrata continuamente contro di loro? E perché non si difendono con la violenza da coloro che le maltrattano? Perché ci sono così pochi omicidi per legittima difesa? Sì, sappiamo che noi donne siamo educate a non esercitare la violenza fisica e che, storicamente, non siamo state parte di eserciti o istituzioni che fanno uso della forza; che da bambine non giochiamo giochi che implicano violenza, che siamo educate per curare e sopportare, per non rispondere alla violenza con la violenza, ma con lacrime e preghiere. Tutto questo implica un grande freno fisico e psicologico alla possibilità di usare la violenza in alcune circostanze ma, tuttavia, sono numerose le occasioni in cui le donne hanno superato questa barriera.
Le donne imbracciano spesso le armi; le donne partecipano e hanno sempre partecipato a sommosse, guerre o rivoluzioni. Le donne oggi sono militari, terroriste o guerrigliere; mettono bombe, dirottano aerei, fanno parte con naturalezza dell’esercito. Meno degli uomini, certo, perché i ruoli di genere mettono loro dalla parte della guerra e non noi, ma anche così, questa barriera non è mai stata impenetrabile. Le donne hanno preso le armi per difendere le proprie famiglie, i propri paesi, le proprie divinità o le proprie idee. Le donne muoiono e uccidono lottando contro il capitalismo, contro un’invasione, contro il colonialismo, il razzismo, la povertà, contro il comunismo o contro l’influenza straniera. E tuttavia, non hanno mai preso le armi per difendere sé stesse dal patriarcato. Le donne muoiono e uccidono, ma mai per sé stesse; e nel caso, contro il patriarcato, uccidono sé stesse, si suicidano. Perché? Perché questa idea suona completamente folle? Mi riferisco ai patriarcati più barbari, mi riferisco all’obbligo di nascondersi sotto un burka, al divieto di uscire di casa, ai matrimoni forzati, alle lapidazioni, agli stupri, al divieto di studiare … E mi riferisco in particolare a quando queste circostanze sono “nuove”, cioè quando si verificano dopo periodi di patriarcati “normalizzati”; il caso dell’Afghanistan è il più noto, ma non è l’unico. La domanda che mi faccio sempre è: perché donne che hanno studiato all’università, che hanno sposato qualcuno per amore, che sono state imprenditore o lavoratore, che hanno viaggiato e camminato per la strada normalmente, non si sono organizzate in gruppo armato prima dell’arrivo dei talebani? Perché per noi è molto più facile optare per il suicidio, che per l’aggressione ad altri, anche in circostanze come quelle menzionate? E anche conoscendo le risposte che spesso vengono date a questa domanda, a me non basta; riconosco le barriere, i freni psicologici, ma… Mai? Nemmeno in questi casi?
Se ci riferiamo alla possibilità di esercitare la violenza individuale per rispondere alla violenza individuale, mi assalgono gli stessi dubbi. Recentemente ho discusso con qualcun@ sul fatto che il patriarcato si sia instaurato a causa della maggiore forza fisica degli uomini. Sebbene qualsiasi sistema di dominio usi la forza come strumento, questa non è indispensabile. Il nucleo del potere consolidato è sempre simbolico e infiltra la costruzione personale; altrimenti la resistenza si manifesterebbe immediatamente. Per esempio, esistono – e sono esistiti già in passato – gruppi umani in cui il potere è detenuto dagli anziani, che sono fisicamente i più deboli. Inoltre l’intelligenza, l’organizzazione o le armi possono ben sostituire la forza fisica. La forza fisica non è fondamentale quando si può afferrare un’arma, e vi sono paesi in cui le armi sono a disposizione di uomini e donne.
La forza deriva sempre da un potere simbolico, e questo stesso potere serve anche per privare altr@ del potere. Nel caso del patriarcato, la forza fisica fa riferimento al potere simbolico di genere che dipinge tutti gli uomini come assai più forti fisicamente di tutte le donne, anche se questo non corrisponde al vero in molti casi specifici o non deve essere sempre così. E questo potere simbolico dà loro una forza reale, del potere, mentre allo stesso tempo indebolisce le donne e le lascia immerse in un’impotenza fisica e psicologica assoluta.
Per combattere la violenza maschile, come femministe, intendiamo usare la forza, simbolica e reale, della legge. E’ vero che se la legge condannasse e perseguitasse questa violenza, se si utilizzassero le risorse per l’educazione contro di essa, se la condanna sociale fosse totale, lentamente faremmo passi avanti. Tuttavia, nel caso del dominio patriarcale, la legge è solo uno strumento, ma non è l’unico, perché per quanto si condanni e punisca la violenza contro le donne, se lasciamo intatto il sistema di dominazione simbolica, la violenza esisterà sempre, anche se punita e condannata. Questo sistema è perversamente perfetto e mentre punisce da un lato, incoraggia la violenza simbolica dall’altro. Mentre legifera a favore della parità, si approvano o semplicemente si incoraggiano comportamenti, abitudini, rappresentazioni, leggi o istituzioni chiaramente ineguali.
Quindi la lotta contro la violenza di genere passa attraverso le leggi, passa attraverso l’educazione alla parità, ma passa anche attraverso qualcosa di molto più complicato, quale è l’aspetto simbolico, culturale. Nell’ambito culturale, il potere di autodeterminazione delle donne deve esprimersi anche sul piano fisico, perché le ragazze sono educate alla convinzione che tutti gli uomini sono più forti di loro e che, di fronte ad un’aggressione, possono ricoprire esclusivamente il ruolo di vittime. Tutti i giochi femminili, l’esercizio fisico che (non) fanno, l’abbigliamento, le scarpe, i movimenti, il linguaggio del corpo e persino il vocabolario che usiamo, tutto va nella direzione di togliere forza fisica alle donne. I ragazzi, però, non vengono educati nel timore dei ragazzi forti, ma nella coscienza dell’uguaglianza. Anche le donne possono anche essere forti, ma soprattutto, possono essere, sentirsi, fisicamente alla pari. Il punto non è promuovere l’uso della forza, ma non sentire barriere, blocchi, paure o sentimenti di impotenza di fronte ad altr@ presenze corporee e anche riguardo al proprio stesso corpo.
In questo senso vorrei raccontarvi qualcosa del mio rapporto speciale con la forza fisica. Siccome ho sofferto di poliomielite alle gambe, la mia famiglia decise che sarebbe stato molto importante rafforzare il resto del mio corpo per compensare. Mi hanno fatto fare ginnastica da quando avevo tre o quattro anni. Ho fatto ginnastica per rafforzare il corpo in generale, in particolare i muscoli delle braccia, tutti i giorni della mia infanzia e adolescenza. Ogni pomeriggio dopo la scuola ho trascorso due ore con un’allenatora facendo le parallele, l’arrampicata con la corda, gli addominali e il sollevamento pesi. A causa di ciò, ero una bambina molto forte, insolitamente forte rispetto a come sono le bambine di solito, e anche i bambini. In realtà, ero la personcina più forte nella mia classe, cosa che mi ha fatto avere un diverso rapporto con il corpo rispetto rispetto a quello che di solito hanno le bambine.
Se si doveva salire su di un albero, scalare una parete o trasportare qualcosa chiamavano me.
Se giocavamo a qualche gioco in cui la forza era importante, tutti mi volevano in squadra. I bambini a volte si picchiano, spingono, hanno relazioni mediate dal contatto fisico senza che ciò debba finire in combattimento. Queste relazioni sono state per me una forma di espressione naturale e tutto ciò ha avuto conseguenze, ha determinato il mio inserimento nel gruppo dei bambini, e non delle bambine. Non si faceva nel mio caso il confronto per capire se ero più forte o più debole degli altri, di pochi, o della media. Ero una in più. La cosa importante non era la forza concretamente misurabile, ma l’uso che facevo del mio corpo, della mia forza fisica, quella che fosse; la sensazione era di essere uguale agli altri bambini.
Gli uomini che picchiano le donne non lo fanno perché sono più forti e sicuri di vincere la lotta. Le picchiano perché sanno che in ogni caso la vittima non si ribellerà. Ricordiamo che la violenza del partner maschile in una coppia è un’escalation in cui tutto comincia con un insulto o uno schiaffo a cui lei non risponde mai. Che sia chiaro che non intendo affatto banalizzare il problema della violenza maschile, e non sto suggerendo che la risposta ad essa sia di restituire i colpi. Ma credo che molti degli uomini che picchiano le proprie mogli non siano particolarmente forti, né coraggiosi, e non colpirebbero nessuna se immaginassero che questa qualcuna è capace di resistere. Picchiano una donna perché sanno di poterlo fare, perché è completamente impotente, anche fisicamente.
Conosco bene i meccanismi psicologici che portano molte di queste donne a non lasciare i propri aguzzini, a non denunciarli, a non combatterli; so quello che ci fa ‘l’amore romantico’, la dipendenza affettiva e materiale, ecc. Comprendo che parliamo di un sistema naturalizzato che si rende invisibile, che si manifesta nel simbolico, nello psicologico, nell’autocostruzione personale, che spesso non percepiamo in quanto sistema di oppressione; si manifesta in tanti piccoli atti quotidiani contro cui è difficile ribellarsi, che coinvolgono la famiglia, le persone care, i figli e le figlie. Comprendo che la repressione che viene agita contro le donne che rispondono agli attacchi è stata storicamente terribile, e ancora oggi è orrenda in molte parti del mondo. E il femminismo fa molto per combattere tutto questo. Voglio solo dire che, come parte della nostra lotta femminista, dobbiamo imparare a posizionarci nel mondo con una corporeità autodeterminata, forte, coraggiosa e consapevole; che ciò contribuirà – contribuirà solamente – a cambiare alcune cose. E comunque, torno alla domanda iniziale.
Al di là della violenza machista in particolare, per quale ragione le donne mai, mai si sono organizzate e hanno preso le armi per difendersi, almeno in situazioni straordinarie? Questa domanda mi passa continuamente per la testa senza che io riesca a trovare una risposta – Mai?
(Articolo originale qui. Traduzione di feminoska, revisione di Serbilla Serpente.)