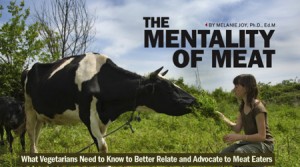Continua da qui
Continua da qui
“La nostra esperienza primordiale, preconcettuale… è intrinsecamente sinestesica”(12), scrive David Abram. Cita Merleau-Ponty nell’affermare che esiste uno “strato primario dell’esperienza che precede la sua divisione in sensi(13) separati”, e che la ragione per cui non siamo consapevoli del primato della sinestesia nella percezione è “perché la conoscenza scientifica sposta il centro di gravità di esperienza, in modo tale che abbiamo disimparato a vedere, sentire e, in generale, percepire, al fine di dedurre dalla nostra organizzazione corporea e del mondo per come il fisico lo concepisce, che cosa dobbiamo vedere, ascoltare e sentire(14).” Lo scienziato contrasta la percezione selvatica o bestiale esplorando le pareti della grotta buia del mondo con una piccola torcia elettrica, poco a poco, la totalità solo successivamente assemblata nel pensiero(15). La divisione sociale del lavoro e la lotta che ne consegue sono correlate alla frattura all’interno del corpo umano individuale e fenomenico.
La società capitalista divisa in classi ha, sopra ogni cosa, lo scopo di disciplinare la carne per imporre il lavoro di accumulazione del capitale come prevalente su tutti gli altri aspetti della vita quotidiana. Degli innumerevoli esempi possibili, prendiamo in considerazione l’azienda cinese Foxcomm, la più grande produttrice mondiale di elettronica che assembla, tra gli altri, i computer Apple. Nel solo 2010, diciotto dei suoi operai hanno tentato di suicidarsi lanciandosi dal tetto degli edifici aziendali. Quattordici sono morti. Durante le recenti proteste, circa 150 lavoratori hanno minacciato di gettarsi. Quale soluzione è stata messa a punto dalla dirigenza? Hanno affrontato le cause di disagio dei lavoratori? Non hanno assolutamente fatto nulla di ciò. Invece, hanno messo a punto una “non-soluzione” che è tanto ovvia quanto scandalosa: dopo la prima ondata di suicidi, hanno installato enormi reti di sicurezza per evitare ulteriori salti(16). Cerchiamo di immaginare lo scenario non così improbabile che potrebbe svilupparsi, quello in cui i lavoratori e i loro responsabili si spingano sempre più in là, cercando di superarsi in astuzia l’un l’altro, realizzando un vero e proprio spettacolo di tecno-efficienza e disperazione. Ora, quanti di noi utilizzeranno computer Apple per scoprirlo?
In India, i suicidi degli agricoltori legati alla “crisi agraria” sono diventati normali. Si stima che circa 17.000 agricoltori si siano suicidati nel solo 2009. Quando i prezzi sul mercato azionario scendono, a migliaia perdono il proprio sostentamento. L’Indian National Crime Records Bureau dichiara che circa 216.500 sono morti per questo motivo nel periodo 1997-2009(17). Nella produzione del cotone, ad esempio, si fanno soldi in tutto il mondo in stretta relazione con le fluttuazioni dei prezzi che hanno causato queste morti. Come il mercato azionario dell’attore aziendale e le sue massicce sovvenzioni statali, il suicidio di massa è una questione di calcolo statistico nel solito giro di affari, e nulla di più.
Non dovrebbe essere difficile spiegare come il sentimento di orrore di fronte a “sistemi, sistemi razionali, razionali tra virgolette, strumentalmente razionali” sia di per sé logico(18). Date per scontate, le decisioni individuali dettate dal senso comune e volte alla soddisfazione di interessi immediati risultano, tutte insieme, in esiti irrazionali. Per esempio, migliaia di persone salgono sulle proprie auto, desiderando di tornare a casa il più presto possibile dopo una dura giornata di lavoro, per poi ritrovarsi bloccate nel traffico nel bel mezzo della strada, soffocando nello smog e lì bloccate per ore e ore. E questo scenario si ripete ogni giorno mentre si parla di “rivoluzione verde,” un assurdo kafkiano trasformato in un universale normalizzato.
L’alienazione delle relazioni sociali, altrimenti naturali, è resa comprensibile solo in maniera mediata – attraverso la scrittura, la musica, l’arte. Incorporata saldamente nel cuore di abitudini non liberamente sviluppate, ma generate in maniera coercitiva dalle strutture materiali e ideologiche della produzione, l’alienazione è qualcosa che si conosce, ma che non si può riconoscere profondamente se non attraverso un qualche tipo di mezzo attraverso il quale il corpo possa riconnettersi con se stesso in maniera sicura, ampiamente e preventivamente programmata. In una buona società (ossia, non alienata) queste mediazioni sarebbero inutili; la loro sopravvivenza segnala, soprattutto, le carenze della vita umana. Adorno apre la sua Dialettica negativa scrivendo che “la filosofia, che un tempo sembrava superata, continua a vivere perché mancò il momento di realizzarla.”(19)
Nel frattempo, la nostra esperienza è in declino, ridotta in gesti riprodotti meccanicamente, ritualizzati, sempre più standardizzati. Come spesso accade con ciò che viene dato per scontato e con ciò che si vuole dimenticare, i fondamenti della vita corporea, la nostra vitalità sensuale e la nostra partecipazione sensoriale, sono stati spinti sullo sfondo dallo spirito della rinuncia. Pertanto, mentre la carne soggiogata sommessamente costituisce e ricostituisce tutta la vita senziente, per la maggior parte rimane invisibile. Ma le cose cambiano. In un primo momento a poco a poco, poi convulsamente, il tessuto della normalità è rotto, e una nuova intuizione si riversa forzatamente nei nostri occhi mentre assistiamo a un ritorno del rimosso.
La vita sensuale riemerge in bella vista in sintomi morbosi: ossessione dilagante e compulsione, depressione e apatia, ansia, irritabilità e aggressività, obesità, dipendenza dal lavoro, ipertensione, solitudine, intorpidimento, noia, stanchezza cronica nel bel mezzo di un sovraccarico sensoriale, suicidio, dipendenza da internet, malattie cardiache, la violenza assoluta dell’omicidio seriale e della guerra organizzata – la nostra natura selvaggia sta diventando perversa, implodendo su se stessa o esplodendo nel mondo. Tutto questo viene compensato con rimedi rapidi – un volo nell’artificialità intensificata della desublimazione repressiva (20), la farmacologia, l’ingegneria genetica e l’incarcerazione.
Il ventre molle dell’esistenza reificata risiede nella pervasività del tecno-produttivismo: ogni problema è una questione di tecnica e richiede una soluzione tecnica, e le soluzioni tecniche comportano la manipolazione sistematica dei simboli e delle cose. Soffocando efficacemente la sensibilità del corpo, le procedure amministrative e le catene di comando sono rapidamente ristabilite mentre pseudosoluzioni lasciano intatte le cause dei problemi, che verranno affrontate da ulteriori azioni alienate. Interessata principalmente a svincolarsi da situazioni vissute, e non solo questa o quella volta, ma a risolvere questo o quel problema una volta per tutte, la mente scientifica eccelle nel regno dell’astrazione. Non c’è nulla nell’atteggiamento scientifico che si frapponga al nostro svegliarci un giorno a darci pacche l’un l’altro su spalle cyborg appena acquistate con le nostre nano-armi, o con i nostri nuovi io disincarnati caricati su dischi rigidi. E questa attitudine si sta diffondendo a macchia d’olio. Per parafrasare Alan Watts, staremmo tutti indossando camici bianchi, se potessimo farlo. Siamo tutti tecnici oramai(21).
Atrofizzandosi, l’anima umana carnale si trova a fronteggiare un mondo alieno attraverso la lente di un sistema che vanta diversità, ma si fonda sulla quantificabilità universale della merce(22), un sistema che promette profondità, ma si ritira, a poco a poco, nella piattezza dell’immagine(23). Per quanto tempo può durare? Per quanto tempo al corpo vivente, risucchiato dal gorgo del capitalismo industriale, sarà chiesto di negare se stesso, sacrificato sull’altare della produzione? E quanto peggio stanno i miliardi di altri corpi che condividono il mondo con noi. Manipolati nella schiavitù, una legione di altri animali occupa i vasti spazi recintati, ingabbiati e reclusi di un’economia schiavista globalizzata.
§ … e tutti gli Altri
Con le incessanti trasformazioni della natura, la morte diviene un dato di fatto e riempie il cuore umano con un terrore che s’irradia in ondate di violenza crescente e sistematica. L’emergere di un programma distinto volto all’auto-stabilità umana di fronte all’inevitabile è stato reso possibile dalla precedente degradazione degli altri animali a portata di mano dell’uomo. Ora, il quesito scottante resta di determinare chi sia compreso nella categoria homo sapiens, e chi ne sia escluso. Nella lotta per l’emancipazione degli Afro-Americani negli Stati Uniti, Malcom X poté affrontare la questione con le seguenti, ben note, parole,
Diritti umani! Rispetto in quanto esseri umani! È questo che le masse di neri americani vogliono. È questo il vero problema. Le masse di neri non vogliono essere degradate come se fossero appestate. Non vogliono essere murate vive nelle baraccopoli, nei ghetti, come animali. Vogliono vivere in una società aperta e libera, dove possano camminare a testa alta, in quanto uomini e donne(24).
In altre parole, l’obiettivo per i neri è di essere liberi come esseri umani, invece che non liberi come animali. Indipendentemente da quale sia la nostra razza o etnia, abbiamo costruito il senso di un’identità umana immutabile sulle schiene spezzate di altri animali, per elevarci – nella nostra pratica economica, nel nostro senso comune, nella nostra sensibilità religiosa e nelle nostre scienze – verso quella che Merleau-Ponty ha chiamato “contemplazione dall’alto”(25). È dai corpi non umani – cacciati, controllati, stuprati e allevati, tenuti in cattività e macellati, sfruttati e utilizzati come cavie – che abbiamo imparato la maggior parte di ciò che sappiamo riguardo a come nuocere, mutilare, torturare e uccidere.
Le vittime spaziano da quelle definite in modo mirato (come il cosiddetto topo marchiato OncoMouse, sezionato nei laboratori in nome della ricerca sui trattamenti per il cancro) ai danni collaterali (come gli abitanti della foresta amazzonica, sterminati dal disboscamento della loro casa perpetuato per permettere il pascolo di mucche in schiavitù). L’olocausto animale globale è così pervasivo che è difficile stabilire il confine tra intento assassino e morte accidentale. Il solo numero di animali terrestri uccisi per fini alimentari è di 56-60 miliardi l’anno(26). Oltre ciò, e agli animali marini non contabilizzati, l’attuale ondata di estinzione di specie animali – soprannominata dai principali ricercatori come “La Sesta Grande Estinzione” – è la più vasta degli ultimi 65 milioni di anni, quando scomparvero i dinosauri(27). Juliette Jowit, del The Guardian, afferma che
L’IUCN (International Union for the Conservation of Nature−KF) nel 2004 dette origine a ondate di reazioni con la sua importante valutazione sulla biodiversità mondiale, secondo la quale il tasso di estinzione aveva raggiunto una cifra 100-1.000 volte maggiore di quella suggerita dalla datazione dei fossili nel periodo antecedente la comparsa degli esseri umani(28).
Aggiunge che mentre
Da allora non sono stati pubblicati calcoli ufficiali… i conservazionisti concordano che il tasso dell’estinzione è aumentato da allora, e … è possibile che siano corrette le drammatiche proiezioni fatte da esperti come il rinomato biologo di Harvard E.O.Wilson, che prevedono, in un ventennio, un tasso di estinzione fino a 10.000 volte quello di base(29).
La pressione ecologica esercitata sugli habitat di altri terrestri e sui loro stessi corpi da parte di industrie umane essenzialmente parassite è incredibile e senza precedenti.
Le vittime animali del passato e del presente, che segnano il percorso insanguinato dello sviluppo capitalistico-civilizzatore, chiedono un riscatto nelle urla quotidiane di milioni e miliardi di gole tagliate. Un riscatto non è possibile – come potrebbe esserlo; e, in ogni caso, le urla restano inascoltate. La crisi della sensibilità (capacità di percepire con i sensi) ha serie ripercussioni sul modo in cui la violenza è perpetrata: l’orrore dei macelli e dei laboratori di vivisezione è in genere nascosto alla vista e, con l’aumentare della distanza tra corpi sensibili, pervade i mondi abitati delle vittime(30). Anche gli zoo si preoccupano affinché la profondità della sofferenza degli animali rimanga invisibile, nascondendola in modo scrupoloso con un’esposizione palese ed esagerata: vedendo troppo, perdiamo di vista il reale(31). Al massimo la violenza viene raccontata, e ciò non è abbastanza.
Patiamo la mancanza di un contatto diretto, sentito e sensoriale con il mondo, nonostante esso sostenga ogni nostro passo. La mediazione – il filtro tra il mondo e il nostro corpo che conosce il mondo – è lo strumento del distacco, e il distacco è il prerequisito dell’oppressione. La materia resiste alla fredda analisi. Niente sembra essere completamente accidentale, né profondamente compreso.
L’orrore eterno subito da esseri fragili è sia al di là di ogni comprensione, sia reso incredibilmente normale. In maniera acuta, Karen Davis scrive che
[p]er quanto riguarda i miliardi di polli, di tacchini, di anatre, di bovini, di maiali e degli altri animali che, come i loro corrispettivi selvatici, si sono evoluti a condurre vite sociali complesse nei loro habitat naturali e hanno dimostrato di essere in grado di ritornare a vivere in modo indipendente dagli uomini – ovvero – di ridiventare selvatici – il destino genocidario non è quello di essere estinti fisicamente, ma quello di proliferare con trasformazioni virtualmente infinite e strazianti dei loro corpi; trasformazioni al fine di renderli adatti a quei letti di Procuste che sono l’industria agricola e la ricerca(32).
Le pratiche industriali sono tutte pianificate, programmate, chiaramente definite, riproducibili, sistematiche e ambiscono alla prevedibilità e non-ambiguità. In quanto parte di un’intensificazione ed esternalizzazione di quella fuga, antica come l’uomo, dalla nostra condizione animale, la moderna oppressione degli animali fa parte di una serie di olocausti che, per la loro portata, ci invitano a mettere in prospettiva Auschwitz, Treblinka, Chełmno, e gli altri campi di sterminio(33).
Nell’intreccio di passato e presente, persino da uno sguardo superficiale emergono chiaramente due verità collegate: 1) siamo impegnati in un sistema di dominazione quasi totale e 2) sembra esserci una traiettoria storica riconoscibile, dai toni distintamente cupi: una spirale discendente messa in moto gradualmente da un errore concettuale di base che tuttavia non è facile da tracciare e che di certo non sarà esaminato qui. In tutto ciò deve aver avuto un ruolo importante la zoofobia, intesa come forza ideologica, psicologica e legittimante, “l’altra medaglia” della produzione fin dagli esordi della transizione epocale dalla società di cacciatori a quella civilizzata e agricola. Rendere gli animali schiavi non è stata certo una passeggiata – schiacciargli il collo sotto al piede per sottometterli la prima volta probabilmente non è stato facile. Cacciare è una cosa, ma dominare dev’essere stato diverso.
In contrasto con immagini romanticizzate della prima addomesticazione animale, Charles Patterson ci ricorda che
Nell’uccidere gli animali per la loro carne e sfruttarli per il loro latte, per le loro pelli, o per il loro lavoro, i pastori impararono come controllare i movimenti, la dieta, la crescita e la vita riproduttiva attraverso l’uso della castrazione, limitazioni al libero movimento, marchiature, tagli d’orecchie e di certi strumenti, come grembiuli di cuoio, fruste, sproni e infine catene e collari(34).
Ovunque sia avvenuta, l’addomesticazione a un certo punto ha implicato necessariamente brutalità.
L’obiettivo era “produrre i tipi di animali più utili” per i bisogni dei pastori che “uccisero o castrarono la maggior parte dei maschi per assicurarsi che quello ‘selezionato’ per la riproduzione ingravidasse le femmine”(35). Le pratiche contemporanee di pastorizia ci offrono degli indizi su come la sottomissione degli animali ha proceduto quando è iniziata circa 11.000 anni fa(36). La castrazione è ancora d’importanza capitale con bovini, cavalli, cammelli e maiali ed è attuata di solito squarciando lo scroto e tagliando via i testicoli, a volte con un coltello di metallo o bambù, altre volte con la lama di una lancia. Talvolta i pastori si limitano a legare lo scroto strettamente con una corda, finché i testicoli non si atrofizzano. Realizzando un sadismo particolarmente vivido, i lapponi bloccano la renna, avvolgono lo scroto in un telo e lo masticano con i denti finché i testicoli non sono spappolati. Con una crudeltà altrettanto sconcertante, ci si è ingegnati in modi per sfruttare le femmine per il loro latte e impedire ai cuccioli di averne.
Per esempio, gli uomini delle tribù Rwala uccidono i piccoli di cammello per cibarsene, poi imbrattano un altro cucciolo col sangue di quello morto e lo portano dalla madre. A loro volta i lapponi sporcano con escrementi le mammelle della renna, cosicché i cuccioli non vogliano succhiarle. Per concludere con un esempio di come il movimento degli animali in cattività può essere controllato, Patterson riporta delle genti alle sorgenti dello Sepik, che rimuovono gli occhi dei maiali perforandoli con bastoni, in modo che il liquido fuoriesca dalla cavità oculare, e poi rimettono il bulbo oculare in posizione. In questo modo i maiali non vagheranno troppo lontano. Più avanti poi, saranno uccisi e mangiati(37).
Non appena gli umani iniziarono a sistematizzare il controllo sugli altri animali e a imporre loro con la violenza atteggiamenti sottomessi, divennero padroni della loro vita o della loro morte. Il processo di domesticazione degli animali non è stato poi tanto diverso da quello che rende drogati: la vittima doveva essere “agganciata”, privata della sua indipendenza, e resa dipendente dall’agente oppressore. Il servilismo e l’acquiescenza che apportano alla vittima benefici di breve durata e attimi di sollievo dalla violenza esplicita hanno un grande prezzo. L’animale è stato strappato dal suo mondo e spinto in una realtà aliena, dove vive una vita di seconda mano. Da allora, ha in genere tollerato il suo oppressore e, incapace di fare altrimenti, ha obbedito. E, nel caso avesse mancato di eseguire gli ordini, sarebbe presto diventato evidente chi era il padrone e chi lo schiavo(38).
Chiaramente, come ribadiscono Carl Sagan e Ann Druyan, “una netta distinzione tra umani e ‘animali’ è essenziale quando si vogliano piegare questi ultimi al nostro volere, costringerli a lavorare per noi, indossarli, e mangiarli – senza inquietanti sfumature di senso di colpa o rimorso”(39). Alla cultura che opprime bisogna che sia fornita una narrativa che ponga una netta separazione del contatto diretto e della vicinanza corporea tra oppressore e oppresso, tale che sia attivato un “cambiamento gestaltico”, un inganno giocato alla percezione in cui non vediamo più la realtà per come è, in cui la realtà è occultata da una nebbia concettuale e ideologica. Tuttavia, poiché la narrativa della dicotomia uomo-animale era fin dall’inizio chiaramente falsa, i rimorsi della coscienza non solo non si sono mai acquietati, ma si sono trasformati in odio – un odio talvolta represso e talvolta esplosivo contro ogni apparenza di falsa compostezza.
Un’altra analogia con l’oppressione razzista potrebbe aiutare a illuminare meglio la questione. Nei primi tempi del suo ministero musulmano, Malcom X predicò ai suoi fratelli neri, “Sapete perché l’uomo bianco vi odia? È perché ogni volta che vede il vostro volto, vede il riflesso del suo crimine, e la sua coscienza colpevole non riesce ad affrontarne la vista”(40). Nemmeno una narrativa costruita attentamente di generazione in generazione è sufficiente per cancellare l’impatto causato da un incontro immediato. Una narrativa zoofobica, proprio come una razzista, corre sempre il rischio di essere smascherata, poiché nasconde una realtà che pretende di essere riconosciuta: nel profondo dei nostri cuori, siamo animali auto-repressi che tengono in ostaggio il mondo.
Note:
12 D. Abram, Spell of the Sensuous. Perception and Language in a More-Than-Human World. New York: Vintage Book 1996, 60.
13 M. Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception. Trad. C. Smith. London: Routledge & Kegan Paul 1962, 227.
14 ibid., 229.
15 Alan Watts afferma che lo scienziato deve ancora “necessariamente usare la propria intuizione nel comprendere la totalità della natura, anche se non si fida di essa. Deve sempre fermarsi e controllare la propria comprensione intuitiva con l’esile raggio luminoso del pensiero analitico.” Noi facciamo affidamento su ciò che Watts chiama intuizione, e su ciò a cui io mi riferirei come l’attività percettiva spontanea della vita pre-cosciente, pre-riflessiva, sub-personale, ad un livello straordinario, per ogni nostro movimento, incluso quello del pensiero analitico. Vedi A. Watts, Nature, Man, and Woman. New York: Vintage Books 1970, 62-3.
16 M. Moore, ‘Mass suicide’ protest at Apple manufacturer Foxcomm factory [in:] The Telegraph, 11 Genn 2012. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9006988/Mass-suicide-protest-at-Apple-manufacturer-Foxconn-factory.html.
17 India: 2009 records highest number of farmer suicides [in:] One World South India, Dec 28 2010, http://southasia.oneworld.net/news/india-2009-records-highest-number-of-farm-suicides.
18 Vedi la discussione di Rick Roderick sulla posizione di Marcuse riguardo alla razionalità strumentale, Rick Roderick on Marcuse−One-dimensional Man, http://www.youtube.com/watch?v=WNAKr1TQ0xc.
19 T. W. Adorno, Negative Dialectics, trad. E. B. Ashton. London and New York: Routledge & Kegan Paul Ltd 1973, 3.
20 La desublimazione repressiva è un meccanismo per il quale sono garantite espressioni artificiali controllate e limitate ai desideri e alle pulsioni represse, espressioni legittimate dall’apparato produttivo e infine ritornanti in esso. Così, per esempio, il business della pornografia è una forma di manifestazione inversa della povertà della vita erotica, una compensazione per la precedente soppressione della sessualità, che permette un certo grado di sfogo sessuale in assenza di intimità. Per un’analisi dettagliata vedi H. Marcuse, Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud. Boston: Beacon Press 1966.
21 Per suggerire un modo in cui questo funzioni anche in situazioni abbastanza banali, lasciate che proponga un aneddoto. Una mia amica, una donna, mi ha detto recentemente di essere un’assidua frequentatrice di palestra. Quando le ho chiesto perché ci andasse, lei mi ha risposto: “Per le endorfine che rilascia.” Così uno rimane a chiedersi quanto tempo ci vorrà prima che non ci venga più chiesto se noi stiamo bene, ma se sta bene l’equilibro biochimico dei nostri cervelli.
Impercettibili temi di microanalisi potrebbero rivelare potenti tendenze sociali. Il linguaggio tecnico-scientifico è ormai usato da non-specialisti in aree nelle quali non hanno alcuna competenza specifica. Nondimeno, essendo una sorta di nuova teoria e fede popolare, ha un’influenza profonda e crescente sul modo in cui essi vedono se stessi, gli altri, e il mondo. Per divagare un altro po’, mi sovviene un altro aneddoto, questo dall’autobiografia di Malcolm X.
X scrive del modo artificiale con cui i bianchi approcciano il ballo, come qualcosa che impedisce l’espressione spontanea. Chiarisce che la spontaneità richiede una rinnovata connessione con qualcosa di corporeo e antico, e un liberarsi dalla tecnica. Dice, “ero tra la folla sgomitante – e all’improvviso, inaspettatamente, ho capito. I miei istinti Africani soppressi a lungo esplosero e si liberarono. Avendo passato così tanto tempo in … un ambiente bianco, avevo sempre creduto e temuto che danzare implicasse un certo ordine o schema di passi specifici – così il ballare è concepito dai bianchi. Ma qui, tra la mia gente meno inibita, ho scoperto che si trattava semplicemente di lasciare che i tuoi piedi, le tue mani e il tuo corpo agissero spontaneamente sulla base di qualsiasi impulso venisse stimolato dalla musica.” Vedi Malcolm X, The Autobiography of Malcolm X: As Told to Alex Haley. New York: Ballantine Books 1973, 60, enfasi nell’originale.
22 Federic Jameson sottolinea come “al minimo accenno di qualche variazione del libero mercato … la più standardizzata e uniforme realtà sociale nella storia” ci può essere rivenduta “come la ricca lucentezza della macchia di petrolio di diversità assoluta, e le più inimmaginabili e inclassificabili forme di libertà umana.” Vedi, F. Jameson, The Seeds of Time. Wellek Library Lectures. New York: Columbia UP 1994, 32.
23 Da confrontare con Debord, Society of the Spectacle, trad. D. Nicholson-Smith. New York: Zone Books 1995. A pagina 26 Debord parla della “dominazione della società da parte di cose le cui qualità sono ‘allo stesso tempo percettibili e impercettibili dai sensi.’ Questo principio è assolutamente realizzato nello spettacolo, dove “il mondo percettibile è rimpiazzato da una serie di immagini che gli sono superiori, ma allo stesso tempo di impongono come eminentemente percettibili;” enfasi mia.
24 Malcolm X, The Autobiography…, 278, la prima enfasi nell’originale, la seconda è mia.
25 Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, 27. Mentre la fisica, ad esempio, ha visto qualche cambiamento nella relazione percepita tra il soggetto e l’oggetto, il paradigma Newtoniano per cui i due sono indipendenti e completamente separabili regna ancora, e non solo per motivi pratici, ma come espressione del moderno senso comune. La “visione dall’alto” sopravvive anche in pieno postmodernismo al punto che il linguaggio è considerato un fenomeno esclusivamente umano e onnicomprensivo. Queste due condizioni danno le basi ideologiche alla dominazione antropocentrica; la prima attraverso l’affermazione dell’eccezionalità umana, la seconda attraverso l’estensione del suo fulcro a tutta la realtà concepibile.
26 Vedi GLiPHA (Global Livestock Production and Health Atlas), http://kids.fao.org/glipha per i dati del 2007 forniti da FAOSTAT. Il numero totale di morti cresce stabilmente. Non classificati come bestiame gli animali marini sono solitamente ammassati tutti insieme e pesati, non contati. Il numero delle loro morti annuali è difficile da determinare.
27 Vedi N. MacFarquhar, Trying to Lace Together a Consensus on Biodiversity Across a Global Landscape [in:] NY Times, 29 Sett 2010 (http://www.nytimes.com/2010/09/30/world/30nations.html?pagewanted=all).
28 Juliette Jowit, Warning sounded on decline of species ([in:] The Guardian, Mar 7 2010 (http://www.guardian.co.uk/environment/2010/mar/07/extinction-species-evolve).
29 ibid.
30 MacFarquhar, Trying to Lace Together a Consensus … L’autore scrive che la perdita di specie ha la caratteristica di essere “lontano dagli occhi, lontano dal cuore.” In parte ciò è dovuto alla piccola dimensione degli organismi e analogamente i fattori dati, ma per la maggior parte può essere collegato alla cattiva consuetudine della civilizzazione di agire in modo superficiale a distanza, inclusa la distanza psicologica, dall’oggetto. In questo modo è stato riconosciuto che si aumenta il disprezzo per le conseguenze e si sopprime la compassione per l’altro. Quindi, lo sviluppo economico moderno ha molto a che vedere con le moderne azioni militari nel senso che entrambi includono uccisioni di massa e indiscriminate.
31 Questa è l’argomentazione di Acampora in varie pubblicazioni, per esempio in Extinction by Exhibition: Looking at and Inside the Zoo [in:] Human Ecology Review, vol.5, no. 1, 1998, 1-4.
32 K. Davis, Procrustean Solutions to Animal Identity and Welfare Problems [in:] Critical Theory and Animal Liberation. Ed. J. Sanbonmatsu. Plymouth: Rowman & Littlefield Pubishers, Inc. 2011, 41, enfasi mia.
33 Ch. Patterson, Eternal Treblinka. Our Treatment of Animals and the Holocaust. New York: Lantern Books 2002. Tristemente, persino uno scrittore e pensatore capace come Patterson qua e là separa l’umanità dal regno animale. Di sicuro, sembra farlo proprio nel titolo del suo altrimenti prezioso libro. A suo credito, tuttavia, va detto che affronta la materia estremamente controversa di stabilire un paragone tra olocausti, muovendosi all’interno del delicato terreno nel quale la sofferenza degli Ebrei, Rom, Polacchi etc. tende ad essere sacralizzata, estetizzata e depoliticizzata.
34 ibid., 7.
35 ibid.
36 Zerzan suggerisce che l’addomesticamento di altri animali, o piante peraltro, non fu incontestato. Dice che di fatto “le testimonianze archeologiche in tutto il mondo dimostrano che molto gruppi umani provarono l’agricoltura e/o la pastorizia e poi li abbandonarono, ritornando alle più affidabili strategie della ricerca del cibo e della caccia. Altri rifiutarono per generazioni di adottare le pratiche di addomesticamento dei confinanti.” Vedi J. Zerzan, Twilight of the Machines, Port Townsend, Washington: Feral House 2008, 107-8.
37 Patterson, Eternal Treblinka … , 8-10.
38 La discussione di Barbara Noske sull’addomesticamento animale lo rappresenta come un fenomeno complesso, che coinvolge reversibilità e gradualismo. Scrive, ad esempio, che “Soltanto in numero relativamente basso le domesticazioni sono sopravvissute fino ai tempi moderni. Ciononostante, vi è la tendenza a considerare la relazione di domesticazione come una sorta di culmine evoluzionistico: come se, una volta che una specie sia stata addomesticata, resti in tale stato per sempre. Questo punto di vista corrisponde molto poco alla realtà storica.” Vedi B. Noske, Beyond Boundaries. Humans and Animals. Montréal /NY/London: Black Rose Books 1997, 5-6. Eppure, io concorderei con Patterson che le narrazioni dell’addomesticamento troppo spesso evitano ogni cenno alla coercizione implicita o esplicita, elementi che, anche se in gradi differenti, devono essere stati presenti nella maggior parte, se non in tutti, i casi di addomesticamento.
39 Citato in Patterson, Eternal Treblinka … , 25.
40 Malcolm X, The Autobiography … , 208.
 Devo ammetterlo, la questione fino a qualche anno fa non mi interessava proprio… Fino a quando sono stata felicemente immersa in quell’età nella quale la riproduzione è soltanto uno spauracchio (la gravidanza da evitare perché troppo giovane) nonché una questione teorica rimandabile (apparentemente, come tutte le cose spiacevoli – dalla calvizie maschile all’artrite) in un futuro molto più ipotetico che reale. Ma compiuto il giro di boa (non ricordo nemmeno esattamente quando), la questione dell’avere figli è diventato come un mantra. Sia chiaro, non per me: io sono rimasta, da quel punto di vista, quella di un tempo. E tra tante idee del cavolo che mi sono state inculcate dal ‘braccio amorevole del sistema’ (la famiglia), fortunatamente l’inevitabilità del mio destino di ‘fattrice-in-quanto-donna’ non ha mai attecchito particolarmente nei miei genitori, e di conseguenza, in me… Si, ecco, loro erano più il tipo ‘diventerai-un’-avvocatessa-rampante-e-spietata-vivrai-nella-grande-mela-e-il-tuo-guardaroba-sarà-come-quello-di-paperino-ma-pieno-di-costosissimi-tailleur (Acc…papà e mamma, mi spiace… you lose!). Così sono cresciuta in maniera un po’ più ‘selvatica’ dal punto di vista delle mie gonadi, considerando la questione maternità davvero molto lontana dal mio orizzonte esistenziale. Poi il tempo passa, ti laurei, inizi (tristemente) a lavorare, vai via dalla casa dei tuoi, ti trovi un compagno più o meno fisso, e il mondo intorno subisce una rivoluzione copernicana. Tic, toc, tic, toc, scopri di avere un orologio impiantato nell’utero… E da un giorno all’altro ti ritrovi tutti nelle mutande, per dirla chiaramente. Familiari, parenti, vicini di casa, perfino datori di lavoro… tutti a chiederti se hai dei figli, se ne vuoi, perché non ne vuoi, cioè, insomma, alla tua età… sei strana. Strana io? Cioè, pensiamoci un attimo: PERCHE’ DOVREI DESIDERARE UN FIGLIO?
Devo ammetterlo, la questione fino a qualche anno fa non mi interessava proprio… Fino a quando sono stata felicemente immersa in quell’età nella quale la riproduzione è soltanto uno spauracchio (la gravidanza da evitare perché troppo giovane) nonché una questione teorica rimandabile (apparentemente, come tutte le cose spiacevoli – dalla calvizie maschile all’artrite) in un futuro molto più ipotetico che reale. Ma compiuto il giro di boa (non ricordo nemmeno esattamente quando), la questione dell’avere figli è diventato come un mantra. Sia chiaro, non per me: io sono rimasta, da quel punto di vista, quella di un tempo. E tra tante idee del cavolo che mi sono state inculcate dal ‘braccio amorevole del sistema’ (la famiglia), fortunatamente l’inevitabilità del mio destino di ‘fattrice-in-quanto-donna’ non ha mai attecchito particolarmente nei miei genitori, e di conseguenza, in me… Si, ecco, loro erano più il tipo ‘diventerai-un’-avvocatessa-rampante-e-spietata-vivrai-nella-grande-mela-e-il-tuo-guardaroba-sarà-come-quello-di-paperino-ma-pieno-di-costosissimi-tailleur (Acc…papà e mamma, mi spiace… you lose!). Così sono cresciuta in maniera un po’ più ‘selvatica’ dal punto di vista delle mie gonadi, considerando la questione maternità davvero molto lontana dal mio orizzonte esistenziale. Poi il tempo passa, ti laurei, inizi (tristemente) a lavorare, vai via dalla casa dei tuoi, ti trovi un compagno più o meno fisso, e il mondo intorno subisce una rivoluzione copernicana. Tic, toc, tic, toc, scopri di avere un orologio impiantato nell’utero… E da un giorno all’altro ti ritrovi tutti nelle mutande, per dirla chiaramente. Familiari, parenti, vicini di casa, perfino datori di lavoro… tutti a chiederti se hai dei figli, se ne vuoi, perché non ne vuoi, cioè, insomma, alla tua età… sei strana. Strana io? Cioè, pensiamoci un attimo: PERCHE’ DOVREI DESIDERARE UN FIGLIO? E non penso tanto a ciò che lo impedirebbe in senso negativo (le solite litanie fatte di lavoro precario, garanzia di un futuro di incertezza per il pupo, fino ad arrivare ai problemi globali di sovrappopolazione in un mondo finito, l’inquinamento, financo la minaccia atomica – sto esagerando… più o meno!), ma a quello che la rende un’opzione insensata IN SENSO POSITIVO: guardo alla mia vita di oggi… non ho un figlio, e non mi interessa averlo. Sono alla soglia dei 40, ho un lavoro precario e part-time che mi fa sì guadagnare poco (ma poi ‘poco’ rispetto a quali standard? Non certo per i miei, per i quali il mio guadagno è più che sufficiente a sopravvivere!) ma mi lascia ampi spazi di vera libertà, fatti di tempo da dedicare a ciò che REALMENTE dà un senso alla mia vita… l’attivismo politico, gli animali umani e non umani che condividono la vita con me, le cose che amo fare (leggere, passeggiare in mezzo alla natura, scrivere o disegnare). Sento di avere una vita molto piena (pure troppo!), e anzi, persino quelle 4 ore al giorno che fino ad ora sono stata costretta a dedicare al lavoro per ‘mangiare’ mi paiono ore rubate al mio tempo di vita, tanto che mi sto arrovellando per cercare un modo di limarle ancora un po’!
E non penso tanto a ciò che lo impedirebbe in senso negativo (le solite litanie fatte di lavoro precario, garanzia di un futuro di incertezza per il pupo, fino ad arrivare ai problemi globali di sovrappopolazione in un mondo finito, l’inquinamento, financo la minaccia atomica – sto esagerando… più o meno!), ma a quello che la rende un’opzione insensata IN SENSO POSITIVO: guardo alla mia vita di oggi… non ho un figlio, e non mi interessa averlo. Sono alla soglia dei 40, ho un lavoro precario e part-time che mi fa sì guadagnare poco (ma poi ‘poco’ rispetto a quali standard? Non certo per i miei, per i quali il mio guadagno è più che sufficiente a sopravvivere!) ma mi lascia ampi spazi di vera libertà, fatti di tempo da dedicare a ciò che REALMENTE dà un senso alla mia vita… l’attivismo politico, gli animali umani e non umani che condividono la vita con me, le cose che amo fare (leggere, passeggiare in mezzo alla natura, scrivere o disegnare). Sento di avere una vita molto piena (pure troppo!), e anzi, persino quelle 4 ore al giorno che fino ad ora sono stata costretta a dedicare al lavoro per ‘mangiare’ mi paiono ore rubate al mio tempo di vita, tanto che mi sto arrovellando per cercare un modo di limarle ancora un po’! Allora io mi chiedo, perché? Perché le persone arrivano con tanta inconsapevolezza all’età nella quale scatta quella programmazione sociale che le porta, contro ogni ragionamento e buon senso logico (individuale e collettivo) a sobbarcarsi l’enorme fatica personale/economica/di tempo di riprodursi (nonché ad aumentare il già troppo esuberante numero di persone che già esistono, e che non solo stanno cancellando dalla faccia della terra le altre specie, ma stanno anche faticando sempre di più ad esistere loro stesse – la torta è sempre quella, baby, ma gli invitati sempre di più!)? Il mondo esubera di bambini che vivono in condizioni pietose, perché questo anelito al ‘proprio’ bambino? Cos’è questo rigurgito che sa tanto di smania di proprietà e illusione di propria immortalità (cioè, davvero vi considerate così speciali)?
Allora io mi chiedo, perché? Perché le persone arrivano con tanta inconsapevolezza all’età nella quale scatta quella programmazione sociale che le porta, contro ogni ragionamento e buon senso logico (individuale e collettivo) a sobbarcarsi l’enorme fatica personale/economica/di tempo di riprodursi (nonché ad aumentare il già troppo esuberante numero di persone che già esistono, e che non solo stanno cancellando dalla faccia della terra le altre specie, ma stanno anche faticando sempre di più ad esistere loro stesse – la torta è sempre quella, baby, ma gli invitati sempre di più!)? Il mondo esubera di bambini che vivono in condizioni pietose, perché questo anelito al ‘proprio’ bambino? Cos’è questo rigurgito che sa tanto di smania di proprietà e illusione di propria immortalità (cioè, davvero vi considerate così speciali)? E’ una questione di scelte, del resto. Rispetto a chi ha un lavoro full time e dei figli, io ho meno denaro e più tempo. Non conosco la gioia che possono dare dei bambini, ma nemmeno le rinunce e i dolori. Conosco la gioia della libertà che me ne deriva, dei rapporti altri che coltivo, del tempo che posso dedicare alla mia crescita personale, alla vita in un senso assai più ampio ed inclusivo. Questo guardarmi così mortalmente inserita in un tutto che mi trascende, mi fa sentire assai meno speciale, e d’altro canto assai libera. Perdo qualcosa e guadagno qualcosa, perché ogni scelta presuppone vantaggi e rinunce, e credo che, per la persona che sono, questo sia quanto di più desiderabile possa esistere. Peraltro, ne vedo il grande valore aggiunto di poter avere tempo anche per altr*, la mia famiglia allargata, fatta di quegli animali umani e non umani che già esistono, qui ed ora, e purtroppo, spesso, si trovano in difficoltà.
E’ una questione di scelte, del resto. Rispetto a chi ha un lavoro full time e dei figli, io ho meno denaro e più tempo. Non conosco la gioia che possono dare dei bambini, ma nemmeno le rinunce e i dolori. Conosco la gioia della libertà che me ne deriva, dei rapporti altri che coltivo, del tempo che posso dedicare alla mia crescita personale, alla vita in un senso assai più ampio ed inclusivo. Questo guardarmi così mortalmente inserita in un tutto che mi trascende, mi fa sentire assai meno speciale, e d’altro canto assai libera. Perdo qualcosa e guadagno qualcosa, perché ogni scelta presuppone vantaggi e rinunce, e credo che, per la persona che sono, questo sia quanto di più desiderabile possa esistere. Peraltro, ne vedo il grande valore aggiunto di poter avere tempo anche per altr*, la mia famiglia allargata, fatta di quegli animali umani e non umani che già esistono, qui ed ora, e purtroppo, spesso, si trovano in difficoltà.