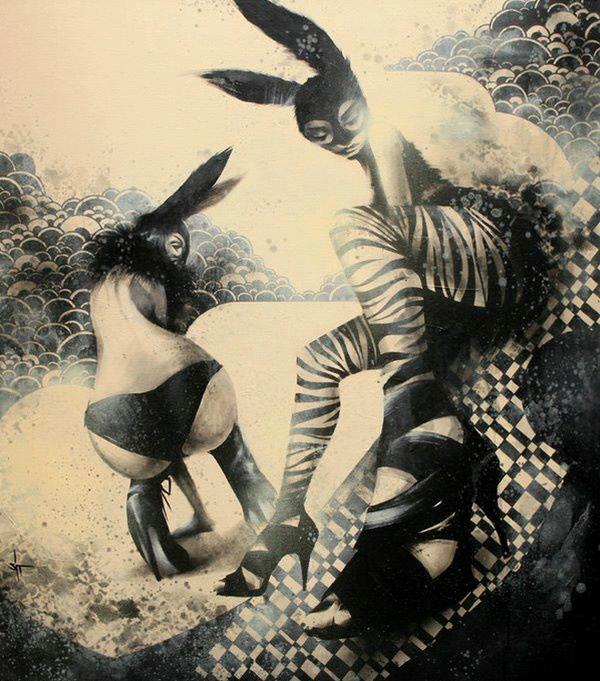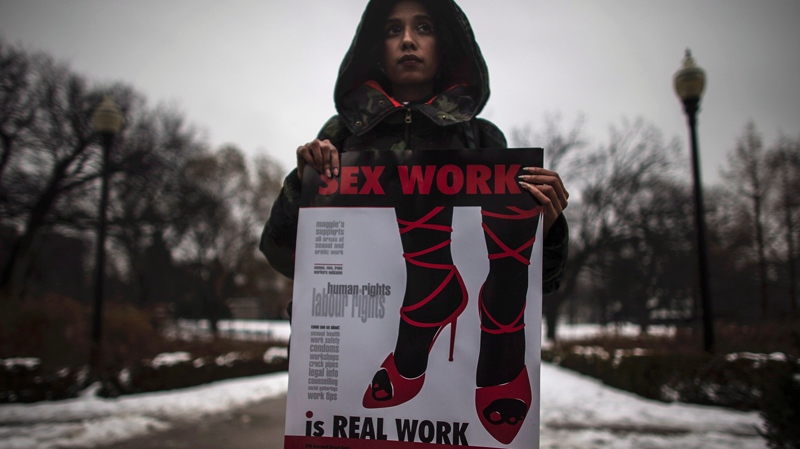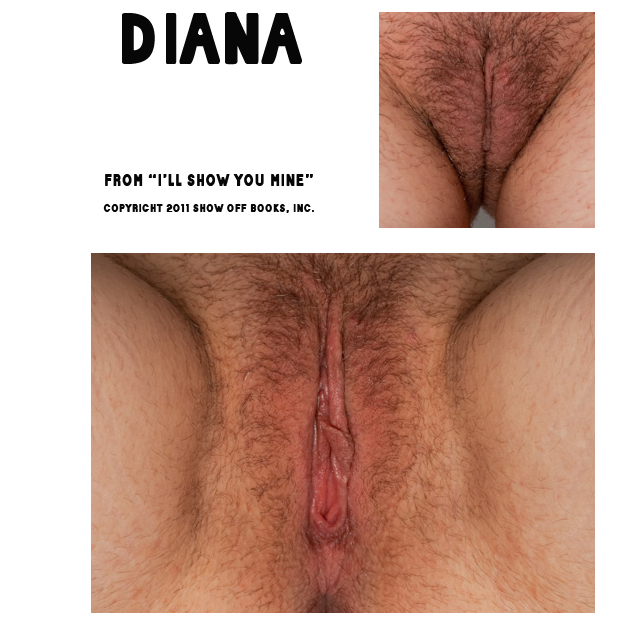di Pattrice Jones, traduzione di feminoska, revisione di Eleonora.
Anche nel caso di questa traduzione sottolineiamo che nel testo viene usato il termine ‘animali’ a designare gli animali non umani; pur rispettando la lettera del testo originale, ci preme sottolineare che animali non umani sarebbe stato un termine più felice, nell’ottica di riaffermare la ns. consapevolezza di essere anche noi animali – seppure umani – ed inoltre perché la dicotomia umano-animale è funzionale a quell’idea di ‘superiorità morale’ dell’animale umano sull’animale non umano che vogliamo demolire (come ben spiegato nella traduzione del testo Farla finita con l’idea di umanità precedentemente pubblicata su Intersezioni)… buona lettura!
Sola su di un palco alla Syracuse University, Sarahjane Blum trema dall’emozione mentre racconta ciò che ha visto all’interno di una fabbrica di foie gras. Ascoltando ma anche vivendo le sue parole, il pubblico assiste alla sofferenza delle anatre attraverso gli occhi di Sarahjane. Quando le parole vengono a mancare, Sarahjane mostra alcune scene del video ‘Delicatezza della Disperazione’. Seduti nella sala buia, studiosi e attivisti vorrebbero sottrarsi, ma si sforzano di assistere alla sofferenza visibile sullo schermo.
Su un banchetto informativo appena fuori dall’auditorium, uno schermo trasmette in loop video di maltrattamenti animali filmati sotto copertura all’interno dei laboratori dell’Huntingdon Life Sciences. Ripetutamente, un uomo urlante in camice bianco da laboratorio compie abusi su cuccioli di beagle. Si possono solo immaginare le elucubrazioni mentali necessarie alle/agli attivisti seduti al banchetto per tollerare la raffica incessante di rabbia umana e sofferenza animale. E che dire dell’attivista che è entrata all’HLS sotto copertura, come dipendente, per far emergere la realtà di tali abusi? Come ha potuto gestire le proprie emozioni in quel momento? Che cosa sente ora?
In un bel pomeriggio di fine settembre, Karen Davis, Presidente di United Poultry Concerns si ferma al rifugio Eastern Shore. È sconvolta, ha appena assistito all’eutanasia di una gallina malata e incurabile dal veterinario. Come sempre, Karen è rimasta con la gallina fino alla fine. Le persone le chiedono di continuo: “Come puoi andare avanti senza sentirti turbata?” Quello che non capiscono, dice, e il tono di voce si fa più alto, è che “io sono sempre turbata!” Tutto quello che può fare, sostiene Karen, è andare avanti, incanalando i propri sentimenti in qualcosa – qualche documento, qualche discorso, qualche parola – in grado forse di fare la differenza.
Il disastro ha colpito un’altra fabbrica di uova. I soccorritori convergono sul posto, cercando di salvare il maggior numero possibile di galline. Migliaia sono già morte. Essendo rimasti senza cibo né acqua per molti giorni, gli uccelli sopravvissuti – intrappolati nelle gabbie con i loro compagni morti – sono ancora più sconvolti delle solite galline in batteria. Qualcuno sbatte le ali freneticamente, altri stanno immobili, i dorsi ricurvi esprimono i loro sentimenti di impotenza. Uno dei soccorritori nota alcune galline intrappolate nelle fosse degli escrementi sotto le gabbie e guada il letame nel tentativo di salvarle, ma deve tornare indietro quando, ormai immerso fino alla cintola, rischia di essere risucchiato. Nelle settimane successive, soffrirà di insonnia, sogni ricorrenti di essere impotente in mezzo ad animali non umani che hanno bisogno di aiuto e ricordi intrusivi degli uccelli che non ha potuto salvare.
Le nostre emozioni animali
Le persone sono animali. Gli animali hanno sentimenti. Gli animali hanno corpi che sperimentano ed esprimono i loro sentimenti. Come tutti gli altri processi fisiologici, i sentimenti persistono anche quando vengono ignorati o negati.
Uno dei miti della superiorità umana è che siamo in grado di trascendere le nostre percezioni, mentre gli altri animali ne sono vincolati. Questo va di pari passo con l’idea che possiamo e dobbiamo superare la nostra corporeità, mentre gli animali non umani vi coincidono sempre. Questa idea è così profondamente radicata in molte culture occidentali ed orientali che anche le/gli attivist* per la liberazione animale possono implicitamente abbracciarla.
Quando ci rifiutiamo di riconoscere i nostri limiti fisici o ci aspettiamo di essere immuni dal fattore emotivo che influenza gli altri animali, siamo pericolosamente vicin* alla mentalità “mente (umana) contro corporeità (animale)” che porta alla biotecnologia e agli altri sforzi per rimodellare il mondo naturale secondo le nostre fantasie di onnipotenza e di controllo.
In realtà la vita segue le proprie regole, non le nostre. Non abbiamo più controllo sulle nostre emozioni animali di qualsiasi altro vertebrato. Possiamo scegliere quello che facciamo dei nostri sentimenti e anche, in certa misura, se sperimentarli pienamente. Ma non possiamo scegliere di non arrabbiarci per le ingiustizie o di sentirci tristi di una perdita, più di quanto un pollo possa scegliere di non avere paura di un falco o di sentirsi frustrato da una gabbia.
I sentimenti possono essere sia spaventosi che seducenti poiché rimangono selvatici, indipendentemente da quanto invece siamo diventati addomesticati noi. Tuttavia, l’unica cosa da temere dei sentimenti è la paura di quei sentimenti. Come fiumi, i sentimenti sono più pericolosi quando arginati o impropriamente incanalati. Come fiumi, fluiranno in ogni caso e possono diventare imprevedibilmente distruttivi, se non gli si permette di seguire i propri percorsi naturali.
Spesso, le/gli attivist* esitano a parlare dei propri sentimenti – o anche a pensarci – perché la sofferenza degli altri animali è, a confronto, molto più grande. I motivi di questa auto-repressione sono altruistici, ma i risultati possono essere controproducenti. Ovviamente, il disagio causato dall’assistere alla violenza non è paragonabile al terrore e al dolore vissuto dalla vittima della violenza. Ma l’angoscia del testimone è reale e non può essere cancellata dai paragoni. Recenti ricerche hanno dimostrato che gli eventi traumatici possono avere un impatto emotivo ugualmente potente sui testimoni e sulle vittime. Sia i testimoni sia le vittime di stupro e violenza domestica, per esempio, possono sviluppare sintomi di stress post-traumatico (PTSD). Secondo la PTSD Alliance, segni di stress post-traumatico possono svilupparsi dopo ogni esperienza che porti a sentimenti di “paura intensa, orrore e senso di impotenza.” L’impotenza di fronte al pericolo per sé o altr* è un enigma per il corpo. I sensi gridano “Questa è un’emergenza!” e il sistema nervoso risponde bloccando la digestione, pompando sangue extra per i muscoli di braccia e gambe, liberando adrenalina nel sangue, rendendo la visione più acuta, e in ogni modo preparando l’organismo a combattere o fuggire. Ma il corpo non ha nulla da fare! Il sistema nervoso mantiene su di giri i motori interni e i sensi continuano a gridare “Emergenza!”, ma non c’è nessun posto per tutta quell’energia ed emozione. Se questa situazione persiste abbastanza a lungo o si ripete abbastanza spesso, l’organismo può venirne danneggiato permanentemente. Era facile notare atteggiamenti come questi durante la prima guerra mondiale, quando i soldati bloccati nelle trincee sopportarono bombardamenti apparentemente senza fine senza poter fare nulla per combattere o difendersi. Molti finirono colpiti da psicosi traumatica, seduti immobili in letti d’ospedale mentre i loro cuori battevano come se fossero ancora sotto il fuoco.
Stress traumatico
Gli americani hanno scoperto lo stress traumatico – come lo intendiamo oggi – sulla scia della guerra in Vietnam. Incubi, flashback e sentimenti debilitanti di paura o rabbia – scoprimmo – erano le conseguenze più comuni dell’esposizione agli orrori della guerra. Come Judith Herman ha ampiamente dimostrato nel suo libro ‘Trauma e guarigione’, è una lezione che abbiamo dimenticato prima ancora di impararla. Ogni generazione cerca di dimenticare i traumi che ha subito e, così facendo, diventa più probabile infliggere un trauma alla generazione successiva.
Un trauma è una lesione o uno shock. Lo stress dovuto all’aver vissuto un evento traumatico, di avervi assistito, o persino di esserne venut* a conoscenza può scatenare reazioni cognitive, emotive o fisiche. Recenti studi sulle persone con PTSD hanno mostrato che episodi traumatici, in particolare quando sono subiti o ripetuti, possono portare a cambiamenti nella chimica del cervello, nel flusso del sangue e nel metabolismo. I liberatori, le persone che compiono investigazioni nei luoghi dove si commettono crudeltà sugli animali non umani, il personale dei rifugi e le/gli attivisti per i diritti animali affrontano e spesso testimoniano direttamente e ripetutamente sofferenze estreme, sperimentando continuamente la combinazione di emergenza e di impotenza che è il segno distintivo di ogni evento traumatico. Come risultato di ciò, spesso lottiamo con disturbi del sonno, ricordi intrusivi ed emozioni troppo acute o al contrario assenza di emozioni.
Se hai livelli elevati di noradrenalina, livelli più bassi di serotonina e un flusso anormale di sangue al cervello, raccontarti che gli animali non umani hanno la peggio non cancellerà i problemi. Se questi problemi ti impediscono di riposare a sufficienza, interferiscono con la tua capacità di concentrazione, o compromettono la tua capacità di mantenere rapporti di lavoro produttivi con le altre persone, allora è probabile che anche l’efficacia del tuo attivismo per gli animali non umani peggiori. Le quattro caratteristiche dello stress post-traumatico sono:
• Tendenza a rivivere l’esperienza traumatica. Incubi, ricordi intrusivi, flashback e forti risposte emotive nel richiamare l’esperienza sono tutti i modi in cui una persona rivive le esperienze traumatiche.
• Intorpidimento emotivo. Può assumere la forma di sentimenti di distacco o estraneità, perdita di interesse per attività solitamente piacevoli, mancanza di sentimenti positivi, o mancanza di qualsivoglia sentimento.
• Tendenza ad evitare ricordi legati all’esperienza. Le persone spesso evitano o addirittura sviluppano reazioni fobiche a persone, luoghi, cose o attività che ricordino in qualche modo l’esperienza traumatica. A volte, cambiamenti di comportamento che sembrano non avere alcun senso risultano essere sforzi per evitare di ricordare il trauma.
• Maggiore eccitazione. Può assumere la forma di una reazione amplificata a rumori forti o altri stimoli, ma anche di una maggiore soglia di vigilanza nei confronti tutto ciò che riguarda il trauma vissuto.
Se subisci un trauma, devi essere pront* ad una reazione di stress. Fai il possibile per prenderti cura di te stess* o permetti ad altr* di farlo, ricordando che – se ci si prende il tempo di farlo immediatamente – puoi così prevenire o attenuare l’emergere di sintomi di PTSD più persistenti e debilitanti. Trova il modo di vivere e di esprimere i tuoi sentimenti, soprattutto parlando con persone che si immedesimino facilmente, ma anche attraverso il movimento, la musica, l’arte, o altre modalità sicure di espressione. Presta particolare attenzione al riposo e all’alimentazione, in modo che il corpo abbia le risorse per far fronte agli aspetti fisiologici del trauma. Se noti che tu o altr* state sviluppando sintomi riconducibili allo stress post-traumatico da un mese o più e che queste reazioni sono causa di disturbo o disagio significativo, è il momento di agire. I gruppi di lavoro – che si tratti di una terapia di gruppo con un terapista o una serie di discussioni tra pari con regole di base in uno spazio sicuro e moderato da un mediatore esperto – possono essere modalità d’elezione per gli attivisti che hanno a che fare con lo stress legato al proprio lavoro con gli animali. La terapia individuale si è dimostrata efficace contro i casi di PTSD legata a un’ampia gamma di traumi. Conosco divers* attivist* animalist* che hanno cercato una buona dose di psicoterapia con psicolog*, assistenti sociali, o altri consulenti professionisti.
Diversi farmaci hanno dimostrato di essere efficaci nel trattamento di sintomi fisici come nervosismo e insonnia. Coloro che evitano i prodotti farmaceutici commerciali a causa della sperimentazione animale, dovrebbero sapere che esistono una serie di rimedi a base di erbe che, in studi clinici con volontari umani, hanno dimostrato un’efficacia pari o superiore a quella dei farmaci sintetici. Consulta un medico qualificato, allopatico o olistico, può aiutarti a decidere se e come trattare i sintomi. Qualunque cosa decidi di fare, non vergognarti di essere un animale. Qualunque cosa senti è la risposta naturale del tuo corpo a ciò che hai vissuto. Nascondere o negare i tuoi sentimenti non li farà svanire, ma potrebbe anzi farti sentire peggio. Al contrario, portare i tuoi sentimenti allo scoperto spesso aiuta ad indirizzarli. Prima li affronti, prima ti senti meglio e sei in grado di fare ciò che desideri.
Depressione.
La depressione è un’altra conseguenza comune dell’esposizione prolungata o ripetuta a ingiustizie e sofferenze. Come nel caso del disturbo da stress post traumatico, la depressione può compromettere in modo significativo la capacità di agire dell’attivista ed è spesso accompagnata da cambiamenti nel sistema nervoso e nel metabolismo. La depressione è una condizione debilitante spesso associata allo stress post-traumatico, ma può anche essere causata da fattori che vanno da una carenza vitaminica temporanea a conflitti intra-psichici persistenti. Chiunque passa attraverso brevi periodi di tristezza che si possono definire “depressione”. Ma si tratta di una depressione diversa dalla depressione clinica, che è una condizione grave che l’Organizzazione Mondiale della Sanità considera una minaccia a livello mondiale. Se non trattata, la depressione clinica può durare per anni senza sollievo. Con un trattamento adeguato, la depressione può sparire completamente o diventare molto più gestibile.
I sintomi della depressione clinica includono:
• Tristezza prolungata o pianto inspiegabile.
• Cambiamenti significativi nelle abitudini alimentari o di riposo.
• Irritabilità persistente, rabbia, preoccupazione, agitazione o ansia.
• Pessimismo o indifferenza.
• Perdita di energia, letargia persistente o stanchezza inspiegabile.
• Sentimenti persistenti di vergogna, senso di colpa, o inutilità.
• Difficoltà di concentrazione o incapacità di prendere decisioni.
• Isolamento sociale o mancanza di interesse per attività precedentemente piacevoli.
• Dolori inspiegabili.
• Pensieri ricorrenti di morte o suicidio.
Se hai cinque o più di questi sintomi per più di due settimane, o se uno qualsiasi di questi sintomi provoca grave sofferenza o disagio, è il momento di chiedere aiuto a un medico. Poiché molti dei sintomi della depressione possono anche essere causati da patologie gravi, è fondamentale parlare con qualcuno che sia qualificato per determinare se la depressione sia il problema primario e, in caso affermativo, decidere quali misure adottare per trovare un po’ di sollievo, mentre si cercano la causa o le cause.
Esistono persino più modalità di trattamento per la depressione rispetto al PTSD. Le terapie cognitive, comportamentali e psicodinamiche hanno dimostrato di aiutare alcune persone che soffrono di depressione. Se un tipo di terapia non funziona, prova una terapia o un trattamento del tutto diversi. Come nel caso del PTSD, esistono rimedi a base di erbe con efficacia dimostrata pari o superiore a quella dei farmaci sintetici, così non devi scendere a compromessi con i tuoi principi per ottenere un sollievo sintomatico. Come nel caso del PTSD, la mente e il corpo influenzano e sono influenzate dalla depressione. Oltre al riposo e alla nutrizione, l’esercizio fisico è molto importante per le persone che convivono con la depressione.
Se qualcuno che conosci sta parlando di morte o di suicidio, non esitare: chiama l’1-800-SUICIDE per avere consigli su cosa fare. Dimentica quello che pensi di sapere su omicidio e suicidio. Parla con persone competenti in materia e ascolta i loro consigli.
Se sei tu che stai pensando al suicidio, ricordati che il suicidio è una decisione irreversibile che non dovrebbe essere presa alla leggera. La maggior parte delle persone che si suicidano lo fanno perché non si rendono conto che possono liberarsi della propria depressione. Puoi sentirti meglio, e succederà, una volta che avrai avuto il tipo di aiuto giusto per te. Allora, avrai a disposizione molti altri anni per lavorare per gli animali non umani. Anche se non credi che riuscirai a fermare lo sfruttamento animale, devi sapere che l’essere salvato è la cosa più importante per ogni singolo animale che viene salvato. Se stai pensando al suicidio, chiama senza indugi l’1-800-SUICIDE, un numero verde locale, il tuo ex insegnante preferito, il tuo migliore amico, o la persona più simpatica del tuo gruppo per i diritti degli animali non umani.
Prima di proseguire, vorrei offrire un pensiero a qualsiasi attivista che stia lottando contro la depressione: puoi non avere alcuna speranza in questo momento, ma io ne ho tanta e te la posso prestare finché non recuperi la tua. Poi potrai passarla a qualcun altr* e saremo pari, perché anche io ho dovuto prenderla in prestito da altre persone in passato. Dico sul serio. Pensaci un minuto e la percepirai. E quando arriverà il momento di trasmetterla, saprai cosa fare.
Ciò che ognun* di noi può fare.
Che ne siano o meno consapevoli, tutt* coloro che si occupano di rifugi per animali, indagini o salvataggi devono gestire le conseguenze naturali di un lavoro emotivamente pericoloso.
Tutt* abbiamo visto cose che nessuno dovrebbe vedere perché tale sofferenza non dovrebbe esistere. Tutt* abbiamo affrontato il peggio che le persone sono in grado di fare e siamo consapevoli che nessuno è veramente sicuro nel mondo perversamente violento dell’attività umana. Siamo tutt* traumatizzati dalla nostra incapacità di fermare la violenza e perseguitat* dai ricordi di animali che non siamo stati in grado di salvare. Sappiamo tutt* che il nostro è un trauma secondario, che il trauma primario è subito dagli animali. Ma sappiamo anche che dobbiamo prenderci cura di noi stess* e delle/gli altr*, anche solo allo scopo di agire in modo più efficace per gli animali.
Stando così le cose, ci sono una serie di cose che gli individui, i gruppi, e il movimento come entità possono fare per aiutarci a essere più in salute possibile nel contesto profondamente malsano del mondo sociale che le persone hanno creato.
Il primo passo è quello di ricordare che sei un animale e che gli animali hanno dei sentimenti. I sentimenti associati con PTSD e depressione sono le reazioni normali di un organismo sottoposto a stress innaturale. Prima impariamo a riconoscere e rispondere ai sintomi di depressione e stress post-traumatico in noi stess* e nelle altre persone, più forte diventerà il nostro movimento.
Strategie personali
Riposati. Stress e depressione sono sia cause che conseguenze dell’insonnia. Da sola, la privazione del sonno può trasformare persone altrimenti felici in persone ansiose, arrabbiate, o abbattute. Se sei già alle prese con sentimenti difficili, la mancanza di riposo adeguato può rendere la lotta più difficile. Riposa il corpo anche se hai difficoltà a dormire. Puoi provare un rimedio di erbe per la mancanza di sonno che non crei dipendenza, come la camomilla, o prendere in considerazione altre strategie per favorire il sonno. Prendi delle vitamine. I corpi sani sono più in grado di sopportare forti emozioni senza crollare. Inoltre, una carenza di alcune vitamine può a sua volta causare depressione. Parla dei tuoi sentimenti. Ascolta quelli degli altri. Esprimi empatia quando si può.
Ascolta il tuo corpo. Dove ti fa male? Che cosa ti aiuta? Che cosa sta cercando di dirti? Ricorda che il tuo corpo ha i propri diritti animali. Non fargli del male. Dagli aria fresca, molto esercizio fisico, e qualsiasi piacere sicuro e consensuale che desideri. Non peggiorare le cose. Le persone a volte cercano di “curare” il loro stress o la loro depressione con alcol o droghe. Se bere in compagnia va bene, bere regolarmente o in maniera compulsiva crea più problemi di quanti ne risolva. Dal momento che l’alcol ha effetti depressivi, le persone alle prese con la depressione dovrebbero evitarlo del tutto.
Strategie collettive
Il tuo gruppo è impegnato in un lavoro che potrebbe portare a stress post-traumatico? Se è così, cosa fa il gruppo per aiutare i propri membri a prendersi cura di se stessi e degli altri? Un gruppo non è altro che un insieme di relazioni. Se queste relazioni sono forti e nutrienti, il gruppo durerà più a lungo e svolgerà più lavoro utile. Il tempo investito nel rendere il gruppo più sano e più solidale sarà restituito con un aumento di produttività e una diminuzione dei tassi di abbandono.
Strategie di movimento
Se potessi, vieterei l’espressione “(x) è niente in confronto a (y)” da tutte le riunioni di movimento e conferenze. Le persone la usano per rimproverarsi le une le altre ed evitare i propri sentimenti di stress e depressione.
I polli “da carne” vivono in capannoni affollati e sono trasportati dai camion verso una morte dolorosa e terrificante a circa sei settimane di età. Le galline ovaiole nelle fabbriche di uova sopportano fino a due anni di tortura nelle gabbie prima di essere trasportate, magari con un viaggio lunghissimo, verso le proprie morti dolorose e terrificanti. Non diremmo mai che ciò che i polli da carne sopportano “non è niente” rispetto a quello che sopportano le galline ovaiole. Anche se è relativamente minore, la sofferenza dei giovani polli da carne è reale e significativa. È particolarmente reale e significativa per loro.
No, il trauma della persona che per svolgere indagini sotto copertura osserva scimmie torturate non è così grave come la sofferenza delle scimmie stesse. Ma non è “niente”. Tutta la sofferenza è reale e significativa, in particolare per chi la subisce. Dobbiamo cambiare l’atteggiamento del nostro movimento verso un’empatia per tutt*, inclus* noi stess*.
Dobbiamo anche iniziare a costruire un’infrastruttura di movimento che aiuti a far fronte in modo più efficace al trauma insito in molte forme di attivismo animale. Perché non abbiamo gruppi di sostegno con moderatori addestrati a tutte le nostre conferenze? Perché non esiste una rete di psicologi per i diritti degli animali che offrano trattamenti gratuiti o a basso costo per gli animalisti che hanno subito traumi? Perché si parla – quando lo si fa – dei nostri sentimenti solo in conversazioni frettolose tra una riunione e l’altra?
Io e la mia compagna gestiamo un rifugio per polli nel bel mezzo di una regione dominata dall’industria avicola. Camion per il trasporto dei polli rombano proprio di fronte alla nostra porta di casa. Non posso dire quanti uccelli siano morti tra le mie braccia. Questo mese sarà il nostro quinto anniversario. Dubito che avrei superato il dolore del primo anno se non fosse per la vicinanza e il sostegno di altre persone che salvano polli. Ci capiamo allo stesso modo – ne sono certa – delle persone che devono affrontare le sfide estreme ed uniche del lavoro sotto copertura. Cerchiamo di trovare modi di sostenerci l’un l’altr* in modo che nessuno di noi si senta sol* nella lotta!
Prima di co-fondare l’Eastern Shore Sanctuary and Education Center, Pattrice Jones ha studiato e lavorato nella psicologia clinica, specializzandosi in terapia individuale e di gruppo per i sopravvissuti ai traumi.