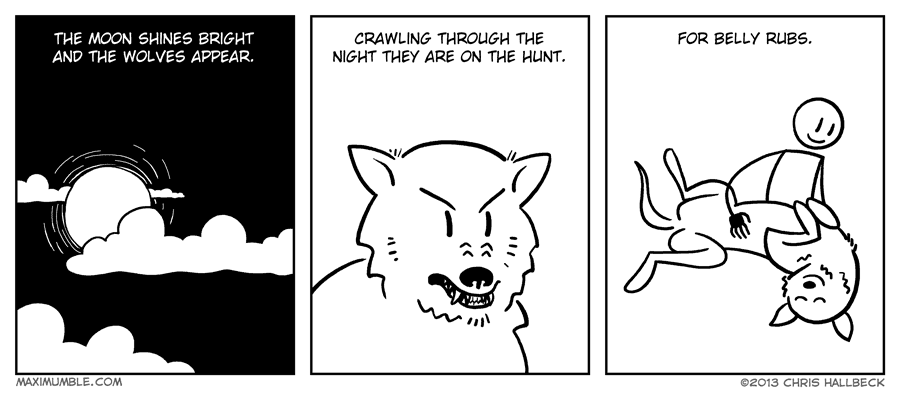Guardo i loro volti agonizzanti sull’asfalto, la bocca aperta per un ultimo, ansimante respiro. In altre immagini, i corpi ormai immobili sono caricati su di un camion con un argano, issati per i piedi, materia senza più vita. Parole di crudeltà mi feriscono nel profondo: “merce”, “carico”. Le vittime contabilizzate sono molte più di quelle dichiarate sui giornali, loro però non fanno parte del computo del lutto, perché non ne sono degni: del resto erano nati per morire. Ed è inspiegabile la tristezza, e la stanchezza. Dover spiegare ogni volta perché quelle vite SONO degne di lutto. Doversi giustificare, trovare motivazioni filosofiche, sociologiche, energetiche, ecologiche, per vedersi riconosciuto il diritto alla compassione, ad una vita il più possibile gentile, il meno possibile crudele. Perché siamo diventat* quello che siamo? Interrogo quel poco che so, ma fatico a trovare una risposta.
Guardo i loro volti agonizzanti sull’asfalto, la bocca aperta per un ultimo, ansimante respiro. In altre immagini, i corpi ormai immobili sono caricati su di un camion con un argano, issati per i piedi, materia senza più vita. Parole di crudeltà mi feriscono nel profondo: “merce”, “carico”. Le vittime contabilizzate sono molte più di quelle dichiarate sui giornali, loro però non fanno parte del computo del lutto, perché non ne sono degni: del resto erano nati per morire. Ed è inspiegabile la tristezza, e la stanchezza. Dover spiegare ogni volta perché quelle vite SONO degne di lutto. Doversi giustificare, trovare motivazioni filosofiche, sociologiche, energetiche, ecologiche, per vedersi riconosciuto il diritto alla compassione, ad una vita il più possibile gentile, il meno possibile crudele. Perché siamo diventat* quello che siamo? Interrogo quel poco che so, ma fatico a trovare una risposta.
E non ho più voglia, davvero nessuna, di dover argomentare attraverso lunghe digressioni quello che sento essere l’unico modo giusto, o perlomeno il più giusto per me, di stare al mondo. Si può fare? Sì. E allora si deve fare. Perché se davvero essere “umani” significa qualcosa – io non lo credo, ma va tanto di moda, da qualche secolo a questa parte, appellarsi all’eccezionalità della nostra supposta umanità – dovrebbe aver a che fare con l’essere compassionevoli, quando in verità a me pare che l’umanità sia, in realtà, l’esatto opposto.
L’essere umano è, per la maggior parte del tempo, assai crudele.
Animale umano di sesso femminile catapultato in questo mondo non per mia volontà, non mi ci è voluto molto a capire che, per quanti privilegi potessi avere (perché sono bianca, perché sono cisgender, perché sono di classe più o meno media, perché ho potuto studiare, perché non ho disabilità *troppo* evidenti) erano altrettante le oppressioni che avrei dovuto affrontare su base quotidiana. E così è stato, e contro quelle oppressioni lotto tuttora, ogni giorno.
Ma ancora prima di tutto questo, ancor prima di sentirmi – e pertanto dichiararmi – femminista, ho sentito in maniera inequivocabile dentro di me uno sdegno intollerabile per quello che viene fatto agli altri animali. E’ stato più semplice e più immediato, perché – ora ne sono certa – non ho mai perso contatto con l’animale che dunque sono. E quell’animale, mai disprezzato, a volte stupito e confuso, non ha mai smesso di com-patire, di sentire e farsi attraversare dall’altr*.
Come si può ridere della sofferenza altrui? Come si può agire con crudeltà, come si può restare indifferenti? Cosa vedono gli occhi distaccati e freddi, quando altri occhi li fissano vitrei ma ancora mobili, ancora in cerca di un altro sguardo a cui aggrapparsi, perché questo è quello che qualunque vivente fa quando sta per morire?
Dove sta nascosta la tanto millantata umanità in quei momenti? E qual’è quel momento in cui, da splendidi bruchi pieni di stupore per la vita crescendo diventiamo farfalle orrende, velenose e assassine? Per quale motivo ci assoggettiamo ad una “realtà” cucitaci addosso con brutalità, invece di lottare, ribellarci e rivendicare la nostra libertà, il nostro desiderio, la nostra felicità? Un cavallo, un’orca, persino un esile merlo hanno più coraggio di noi, e tutti sono disposti a pagare, persino con la vita, quel bene che sanno supremo e non vogliono perdere.
Siamo i più addomesticati tra gli animali, più delle tanto vituperate pecore, delle galline tanto ingiustamente tacciate di stupidità. Siamo codardi e feroci e conformist*. A guardarci con onestà, a fissarci nudi, di fronte ad uno specchio, facciamo davvero paura.
Questo non voglio per me, e spero che nessun* lo desideri. Mi voglio strappare di dosso questa pelle non mia, questa pelle che han cercato di cucirmi addosso e che soffoca l’animale che è in me, in ognun* di noi, rendendolo noncurante e insensibile. Fa molto male, indubbiamente, ed espone ad un continuo e rinnovato dolore. Quella che resta è una pelle sensibile, porosa, che non riesce a proteggere, o almeno non del tutto, dal dolore che permea il mondo e di cui noi, così “umani”, siamo tanta parte. Parrebbe quasi un esercizio masochistico, non fosse che l’alternativa è ancora più agghiacciante, ed è non riconoscere l’altr*, non sentirne le gioie e i tormenti, e in questa distanza invisibile ma incolmabile perdere se stess*, diventare comparse inutili in un copione scritto da altr*.
“No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;
Am an attendant lord, one that will do
To swell a progress, start a scene or two,
Advise the prince; no doubt, an easy tool,
Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous;
Full of high sentence, but a bit obtuse;
At times, indeed, almost ridiculous—
Almost, at times, the Fool.”
E’ questo il motivo, e quasi riguarda più me di loro: perché non voglio perdermi, e voglio poter chiudere gli occhi ogni giorno con il cuore, se non altro, un pò meno pesante.
Ed è perché, assieme al dolore, si ricomincia ad essere attraversat* anche dalla felicità degli animali, che sono capace di soffrire per un camion di maiali.
Ps: Questo era il primo requiem.