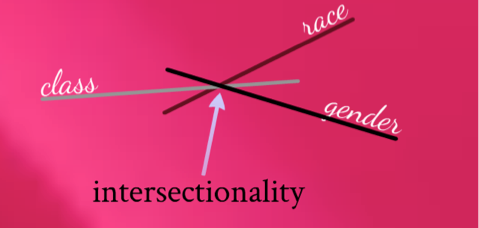Andy Warhol era un profeta.
Davvero molto interessante osservare lo tsunami di commenti che si sono avvicendati sui social, a velocità frenetica, in seguito alla mediatizzazione del caso di Caterina (la nostra riflessione in merito è qui). Quello che colpisce è la quantità di preconcetti, frasi fatte, inesattezze ripetute come mantra a qualsiasi interlocutore, possibilmente farcite di aperto disprezzo, dileggio, ostilità e violenza verbale. Mantenere toni pacati quando qualcun* ti grida in faccia di essere “estremista” – peraltro ignorando qualsiasi tuo tentativo di stabilire una connessione, un dialogo che ristabilisca la possibilità di una riflessione pacata – è davvero un’impresa ardua. Riflettere dunque è quello che cerchiamo di fare qui, e riflettere costa certo più tempo e fatica che insultare e pontificare in 150 parole, ma dal nostro punto di vista, è sicuramente più interessante e produttivo.
Da dove partire dunque? Beh, la tentazione di riprendere per filo e per segno le tante assurdità speciste lette o ascoltate in questi giorni è forte: essendo tutt* nat* e cresciut* in un milieu specista, sarebbe divertente – se non fosse tragico negli esiti per gli animali non umani – rilevare come la mente addestrata ad essere specista dall’infanzia infarcisca di giustificazioni pseudomorali, pseudoevoluzionistiche e financo pseudocreazioniste la realtà dell’uso della violenza che sottende il dominio, il potere, l’assoggettamento schiavistico e utilitaristico dei cosiddetti ‘animali’ (non umani, aggiungiamo noi). L’acriticità con cui si usano i più svariati argomenti, spesso contraddittori, allo scopo di giustificare l’uso della violenza e il mantenimento del privilegio specista è davvero aberrante, di una malafede senza fine e caratterizzato da un dogmatismo raro (un esempio per tutti, nello stesso dialogo si pone la radicale differenza tra ‘umani’ e ‘animali’ (schiacciando in un calderone informe zanzare e scimmie antropomorfe che condividono il 90% del patrimonio genetico con noi, che a questo punto dobbiamo, per mantenere le distanze, elevarci al parnaso dei semidei), per poi usare invece l’esempio dei carnivori obbligati e le attività di predazione come giustificazione dell’uso della violenza -ah, ma allora siamo animali? – e stabilire quindi che anche se siamo così indubitabilmente divers* non lo siamo poi davvero nel momento in cui ci serve utilizzare gli animali per la sperimentazione a beneficio umano… i quali insomma, sarebbero uguali a noi quando ci fa comodo, ma diversi da noi quando gli interessi da salvaguardare sono i loro, e che passano continuamente in uno stesso discorso dallo status di simili a quello di dissimili, senza che nessun* alzi un sopracciglio).
Un vero insulto a quel carattere di intelligenza, moralità ed etica che si presuppone alla radice di tutta questa ‘differenza innata’ tra ‘noi’ e gli altri animali. A volte un sincero “sarà come dite, ma in sostanza me ne frego” sarebbe molto più dignitoso, anche perché le pseudo-giustificazioni ricordano tanto le dinamiche di potere che opprimono le donne su basi ugualmente false e arbitrarie (in bocca a quegli uomini che usano allo stesso modo il proprio potere e privilegio a proprio vantaggio, giustificandolo affermando ad esempio che le donne ‘se la sono cercata’ quando vengono stuprate, che le donne sono ‘naturalmente materne’ pertanto da ricacciare nell’ambito domestico e di cura senza se e senza ma, ecc.ecc.)
A proposito di donne, e a proposito di femministe.
Dal mio punto di vista situato – di donna e femminista antispecista – sento l’esigenza di focalizzare l’attenzione su di un aspetto particolare, nel quale sono incappata diverse volte in questi giorni, per lo più in ambito femminista: il paragone tra animalist* e pro-life, sul quale vorrei spendere qualche parola in più.
Prima di tutto, è interessante notare come le uscite inqualificabili di alcuni individui, identificati come animalist*, ma che non esiterei a definire persone psicologicamente disturbate, siano state usate a pretesto per definire in senso negativo un’intera categoria di persone (e, ancor peggio, ricacciare gli animali nel loro inferno senza ripensamenti o dubbi): una generalizzazione funzionale alla creazione del ‘mostro antispecista’, essere umano che ha voltato le spalle alla propria specie per una forma di perversione o odio di sé o masochismo, che ne fa un essere pericoloso e distruttivo, per sé e per gli altr*. Questa dinamica ha generato una fiumana di reazioni parimenti odiose o anche più estremiste da parte di specist* che però non avrebbero potuto essere messe in discussione nemmeno da un Gandhi redivivo, in virtù di un appiattimento e di una polarizzazione del discorso che ha realizzato un conflitto cieco e violento al pari di quello tipico delle curve di uno stadio alla domenica pomeriggio.
Questa dinamica ha caratterizzato gli scambi anche all’interno di contesti che avrei reputato meno inclini a facili generalizzazioni, come quello femminista, il quale, apparentemente aperto all’intersezionalità – quando parla di relazione inscindibile tra antisessismo e antirazzismo, per dirne una – spesso rinsalda il proprio muro difensivo dogmatico di fronte a qualsiasi tentativo di problematizzazione in senso antispecista, anche di fronte a persone appartenenti allo stesso contesto che, in altre situazioni, non si è esitato a definire “compagne” o “sorelle”… alla faccia della sorellanza!
La dinamica probabilmente dipende da fattori complessi, che passano anche attraverso la difficoltà di esperirsi non solo in quanto categoria oppressa ma anche oppressiva (risulta difficile farlo anche tra diversi femminismi!), dalla ancora relativa invisibilità dell’oppressione specista (un’oppressione è tanto più invisibile quanto più è considerata ‘normale’ dalla maggior parte della persone appartenenti alla categoria che detiene il privilegio), dalla paura tutta femminista di essere ricacciat* in un animalità che, da tempi immemori, è stata la cifra caratterizzante di tutto un discorso volto a dominare i corpi e le vite di donne, persone di colore, diversamente abili, comunità deboli in generale.
Il fatto che lascia perpless* però, è che invece di smascherare i meccanismi che stanno alla base dell’oppressione – ad esempio la creazione arbitraria di una supposta distinzione di valore, atta a dare ad alcuni soggetti diritto di esistenza e di qualità dell’esistenza, a scapito dell’esistenza e della qualità dell’esistenza di altri soggetti – squalificati per le proprie differenze da un ‘esemplare tipo’, di volta in volta ricalcato su chi in quel momento è il dominante (il maschio bianco eterosessuale occidentale in un caso, l’essere umano generico nell’altro) – si cerca semplicisticamente di rientrare nell’insieme privilegiato, senza andare a sradicare il sistema di dominio basato sull’imposizione del proprio potere, perlopiù coercitivo, su altri individui.
Tra le strategie che sono state utilizzate in questo senso, una merita particolare attenzione, ed è quella di paragonare l’atteggiamento animalista (o antispecista, parola che andrebbe conosciuta meglio negli ambiti di attivismo sociale e che è invece altezzosamente ignorata) a quello dei militanti pro-life: un tasto dolorosissimo e sensibile per tutte le femministe, che ha come risultato una chiusura difensiva a riccio, ma a ben vedere un paragone completamente erroneo, come cercherò di far intendere a chi ha avuto la pazienza di leggere fino a qui.
Quello che le femministe faticano a vedere è che, nei fatti, è proprio l’elevazione arbitraria della vita umana a valore insuperabile e inarrivabile tipica dello specismo, una sacralizzazione che va a braccetto con la foga religiosa anch’essa da sempre propugnatrice di privilegi impossibili da scalfire in virtù dell’adesione ad una fede aprioristica (che stabilisce il primato di dio sull’essere umano, dell’essere umano maschile su quello femminile, dell’essere umano in generale su tutti gli altri animali – tutte categorie e ‘caste’ presenti e ricorrenti in tutto il testo biblico a cui si rifanno la maggior parte dei pro-life) a proteggere il feto e ad elevarlo persino al di sopra della donna che lo porta in grembo, che è ridotta a contenitore di ‘vita in potenza’.
Il biopotere, che penetra nelle nostre vite e nei nostri corpi, sottostà alle stesse dinamiche e non fa grosse differenze, che si tratti di animali umani o non umani: anzi, spesso i non umani sono il ‘banco di prova’ di pratiche poi inevitabilmente utilizzate anche in ambito umano.
Pattrice Jones, attivista femminista antispecista, allarga la riflessione ulteriormente, e scrive in proposito:
Esiste in merito una corrispondenza superficiale, perché entrambe le controversie si focalizzano sul disaccordo fondamentale circa le prerogative delle persone in relazione a classi specifiche di organismi. Ma le somiglianze finiscono qui. Diciamo che “la carne è assassinio” perché il mangiatore di carne non ha giustificazioni nell’uccidere un altro essere vivente al solo scopo di provare la sensazione piacevole che può derivare dal mangiar carne. Chi sostiene il carnivorismo offre ogni sorta di giustificazione alla pratica, ma nessuno può mettere in discussione il fatto che l’animale ucciso non è la stessa entità rispetto a chi si nutre della sua carne. La discussione verte quindi sul fatto se sia o meno giustificata l’uccisione, piuttosto che sul decidere se l’animale sia o meno un’entità separata. All’opposto, coloro che si definiscono attivist* “pro-life” definiscono l’aborto omicidio, mentre chi si definisce pro-choice risponde: “i nostri corpi, le nostre vite, il nostro diritto a decidere”. Il fulcro del conflitto risiede perciò nel considerare l’entità abortita un individuo o meno. La maggior parte delle persone concorda nell’affermare che tutt* hanno il diritto di disporre dei propri corpi, fintantoché nel farlo non si nuoccia ad altr*. Allo stesso modo, quasi tutte le persone sono d’accordo nell’affermare che nessuno ha il diritto di uccidere un’altra persona salvo la giustificazione dell’autodifesa. Il problema qui, è il disaccordo che esiste sul quando una donna incinta e il feto che si sta sviluppando diventano entità separate. Non possiamo raggiungere un consenso sull’aborto perché la gravidanza è un processo misterioso. All’inizio del processo esiste una sola persona che ha il diritto di disporre del proprio corpo, mentre alla fine del processo le persone esistenti sono due, e ognuna ha il diritto di non subire violenze da parte di altr*. Dunque nel corso del processo, l’organismo madre-figlio è precisamente il tipo di paradosso che la cultura occidentale non può tollerare: una persona e due individui allo stesso tempo. […] Per questo non sorprende che sia difficile trovare un punto di contatto […] anche tra donne. In questo momento di empasse, sarebbe sicuramente più produttivo se i pro-life e i pro-choice, invece di passare il tempo a dibattere sull’aborto, focalizzassero la propria attenzione su quelle pratiche che sappiamo ridurre le gravidanze indesiderate, quali la contraccezione garantita per tutt*, fare in modo che le persone, specialmente giovani, conoscano i diecimila modi di fare buon sesso che non includono la penetrazione, problematizzare e mettere in discussione quell’idea culturale che vede l’attività sessuale penetrativa alla base di una relazione sentimentale, ponendo la parola fine allo stupro e al sesso non consensuale caratteristico di molte relazioni eterosessuali, e allo sfruttamento sessuale. Se ci concentrassimo su questi aspetti, suppongo che la necessità di aborti diventerebbe così insignificante che smetterebbe di costituire una controversia di tali proporzioni […] Siamo onest*: a nessuna piace abortire. Non è orribile come una gravidanza indesiderata portata a termine, ma non è piacevole. La vera libertà riproduttiva passa attraverso la libertà dalle gravidanze indesiderate. Pertanto, mentre non ritengo la controversia sull’aborto in alcun modo analoga a quella riguardante la liberazione animale, credo che la libertà riproduttiva sia un tema centrale rispetto alla liberazione animale. Che cos’è esattamente il processo di domesticazione? Riduzione in schiavitù combinata a controllo della riproduzione. Come si perpetua l’allevamento? Attraverso il controllo totale delle vite riproduttive degli animali dominati. […] Dobbiamo approfondire e chiarire la nostra comprensione del ruolo centrale che ha il controllo della riproduzione nello sfruttamento, degli animali non umani e delle donne.
Ritornando perciò al concetto di biopotere.
Ribaltando il paragone erroneo tra animalist* e pro-life, ho cercato qui di dimostrare come la difesa del feto attuata dai pro-life scaturisca proprio da quell’idea di unicità inarrivabile e distanza tra l’umano e tutto ciò che non lo è; e di converso, che la biopolitica attuata sui corpi degli animali non umani anche in merito al controllo della riproduzione, è lo specchio e l’anticamera del controllo sempre più pervasivo che viene attuato anche sui corpi umani e la loro riproduzione (in merito perciò all’aborto, alla fecondazione assistita, ma allargando il discorso anche, ad esempio, su eutanasia e fine vita). Lo stringersi delle maglie del controllo da parte del sistema passa attraverso il corpo degli animali non umani, e lo specismo, discorso fondante della nostra società, ha avallato pratiche di dominio vergognose, che in realtà possono ritorcersi contro qualsiasi essere, umano e non.
Finché non abbracceremo un’idea davvero libertaria e rivoluzionaria che sostenga ‘senza se e senza ma’ la libertà e dignità di animali umani e non, finché non la smetteremo di disprezzare nel profondo ‘gli animali che dunque siamo’, non potremo che abbracciare, consapevolmente o meno, le dinamiche di dominio e di potere del sistema che diciamo di voler abbattere il quale sceglie, arbitrariamente e di volta in volta, le categorie da privilegiare e da opprimere.
Ignorare la sofferenza degli animali non umani, in sostanza, fa il gioco di quel potere che opprime da sempre non solo i non umani, ma anche innumerevoli e incolpevoli animali umani, ovvero… noi stess*. E’ ora di aprire gli occhi e rendersene conto.